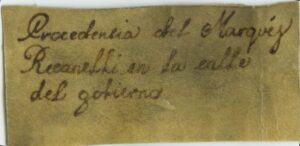LA COLLEZIONE GIUSTINIANI
Caravaggio e i Caravaggeschi

Incoronazione di Spine - Caravaggio
Liberazione di S. Pietro dal carcere - Gerrit van Honthorst
Lavanda dei piedi - Dirck van Baburen
Cacciata dei mercanti dal tempio - Francesco Boneri
Cristo resuscita il figlio della vedova di Naim - Domenico Fiasella
Cristo risana il cieco nato - Domenico Fiasella
Sacra famiglia con S. Giovannino - Jean de Boulogne
Cristo appare alla Madre per annunciarle la morte - Bartolomeo Manfredi
Amore vincitore - Caravaggio
Suonatore di liuto - Caravaggio
Amor sacro e Amor profano - Giovanni Baglione
Amor sacro e Amor profano - Giovanni Baglione
Ritratto di uomo - Jusepe de Ribera
La preghiera del figliol prodigo - Angelo Caroselli
Cena in Emmaus - Nicolas Régnier
Dall'inventario stilato nel 1638 dopo la sua morte, apprendiamo che il marchese Vincenzo
Giustiniani possedeva tredici tele di Caravaggio, tutte collocate nella [ab]stanza grande
de' Quadri Antichi[bb], oltre a due ritratti, uno della matrona Marsilia Sicca, l'altro
del noto criminalista Prospero Farinacci, la cui attribuzione al Merisi risultava dubbia
fin dai tempi in cui fu esteso il documento. Di alcuni di questi dipinti, come il Santo
Agostino a mezza figura, il [ab]quadro grande di una Maddalena a figura intiera[bb] o il
Ritratto del cardinal Benedetto Giustiniani, si sono perse le tracce. Di altri, come il
ritratto rimasto incompiuto [ab]di una cortigiana famosa[bb] o quello del pittore
[ab]Gismondo tedesco[bb], si sono tentate dubbie identificazioni, che non hanno resistito
a lungo al vaglio della critica. Restano così otto quadri, tutti identificati ormai con
certezza, solo cinque dei quali però è stato possibile far tornare, sia pure
temporaneamente, a Palazzo Giustiniani, perché tre di essi, che pure ben conosciamo
attraverso le fotografie, sono andati distrutti durante la seconda guerra mondiale a causa
di un bombardamento che devastò un deposito dei musei di Berlino (ma c'è chi nutre la
speranza che siano stati invece trafugati dall'Armata Rossa e prima o poi saltino fuori a
sorpresa, in Russia o altrove).
Uno di questi tre dipinti andati perduti era un ritratto a mezza figura di un'altra
cortigiana, Fillide, dai lineamenti marcati e dalla bellezza scontrosa. Chiusa in un bel
corpetto ricamato e ornata di vezzi come si conviene al suo stato, Fillide ostenta
un'elaborata chioma corvina e stringe al petto un mazzetto di gelsomini. Assorbita da un
suo pensiero che sembra estraniarla da ciò che la circonda, distoglie lo sguardo dal
pittore che la ritrae e quindi anche da noi che, al pari di lui, la osserviamo
frontalmente. Il secondo quadro disperso era un grande e drammatico notturno con Gesù
nell'orto degli ulivi, che rimprovera gli Apostoli caduti in un sonno profondo e sordi al
suo richiamo. Quest'ultima circostanza è esplicitata in modo insolito e potentemente
espressivo dalla figura sdraiata di Pietro, che non solo volge le spalle a Gesù ma lo
ignora ostentatamente, fissando come ipnotizzato lo sguardo altrove.
Come in altre circostanze, Caravaggio ha fatto posare un modello vivente per questa figura
di Pietro, ma gli ha fatto assumere la classica postura di un'antica statua. Il terzo
dipinto Giustiniani andato perduto in guerra è anche il più noto dei tre: si tratta
infatti di quel celebre San Matteo con l'angelo che doveva fungere da pala d'altare della
cappella Contarelli in S. Luigi de' Francesi, ma che fu poi sostituito da un'altra
versione autografa di Caravaggio. Di recente alcuni studiosi hanno avanzato l'ipotesi che
la prima versione non fosse stata scartata per ragioni di decoro, come tramandano le fonti
seicentesche, ma perché la committenza aveva cambiato idea sul formato del quadro.
Tuttavia sembra davvero improbabile che, in tempi di Controriforma, potesse essere
tollerata l'audacia iconografica di un quadro in cui un evangelista ha l'aspetto brutale e
muscoloso di un facchino e per di più è seduto [ab]con le gambe incavalcate e co' piedi
rozzamente esposti al popolo[bb] (Bellori). Ma più ancora dovette turbare l'ambigua
intimità con cui il bellissimo angelo, avvolto in veli trasparenti, guida l'incerta
scrittura di quel santo analfabeta.
Comunque sia, Giustiniani non esitò ad assicurarsi il quadro e ad esibirlo nella sua
raccolta, non diversamente da come in seguito fecero altri collezionisti di grido, ogni
qual volta una pala del Merisi incappò nei rigori controriformisti e fu rimossa dagli
altari per motivi di decoro.
Ma veniamo ai cinque capolavori di Caravaggio che sono tornati in questi giorni a Roma in
occasione della mostra. Essi appartengono alla fase centrale della carriera dell'artista,
e cioè al decennio che va dalla metà degli anni '90 al fatale 28 maggio 1606, data di
quel famigerato [ab]pasticciaccio brutto[bb] della Pallacorda, che costrinse il pittore a
fuggire precipitosamente da Roma, dove, come tutti sanno, non poté più far ritorno. È
il decennio in cui sono ormai alle spalle gli stenti dei primi, difficili anni romani, in
cui Caravaggio aveva rischiato di rimanere impigliato nel sottobosco della produzione
dozzinale e del quadro di genere. A determinare il salto di qualità era stato l'incontro
decisivo con un mecenate colto e raffinato come il cardinal Francesco del Monte. Questi
aveva accolto il giovane pittore di talento nel suo palazzo (l'attuale Palazzo Madama,
proprio di fronte alla residenza dei Giustiniani) e gli aveva garantito quell'agio
economico, quel nutrimento culturale e quelle occasioni di provarsi nel genere principe,
la [ab]pittura di storia[bb], che lo proiettarono in men che non si dica al centro
dell'affollata ribalta artistica della capitale pontificia: protagonista controverso da
alcuni apertamente avversato ma indiscutibilmente protagonista. Abbandonata la maniera
[ab]un poco secca[bb] dei dipinti giovanili, Caravaggio comincia ad [ab]ingagliardire gli
scuri[bb] e, sviluppando spunti e intuizioni che affondavano le radici nella sua cultura
lombardoveneta, mette rapidamente a punto quel rivoluzionario meccanismo compositivo che
fa emergere le figure dal buio con perentoria evidenza, sorprendendole nell'apice
drammatico dell'azione, bloccate come in un fotogramma sotto la sferza della luce radente.
Il Suonatore di liuto dell'Ermitage è senz'altro il più giovanile dei cinque capolavori
di Caravaggio in mostra e, come tanti altri suoi dipinti coevi destinati alle gallerie di
committenti colti e anticonformisti, è colmo di allusioni dotte e moraleggianti alla
fallace lusinga dei sensi, alla vanità dei piaceri e al trascorrere inesorabile del
tempo, pretesti che, in tempi di Controriforma, fungevano da copertura (o se si preferisce
da dolceamaro contrappunto) all'atmosfera carica di sensualità che si sprigiona da questi
soggetti profani, i cui protagonisti, ambiguamente androgini, esibiscono con consumata
malizia la loro gioventù in boccio. Anche il cardinal Del Monte aveva una versione
autografa del dipinto (oggi è al Metropolitan di New York), in cui però manca la natura
morta con fiori e frutta presente nel quadro Giustiniani. Ma Del Monte possedeva a sua
volta una tela del Merisi, che rappresentava [ab]una caraffa di fiori piena d'acqua[bb]
con gli stessi riflessi e la stessa rugiada che imperla i fiori del nostro quadro. Forse
fu lo stesso Giustiniani a chiedere all'artista di inserire nel suo Suonatore di liuto una
natura morta analoga a quella che aveva potuto ammirare nel palazzo dell'amico cardinale.
Comunque sia, l'episodio è eloquente testimonianza del fitto intreccio di rapporti che
legava tra loro i due mecenati [ab]dirimpettai[bb] ed il giovane che entrambi
proteggevano.
Con l'Amore vincitore degli Staatliche Museen di Berlino e L'incredulità di San Tommaso
della residenza di Potsdam siamo ormai nel pieno della maturità caravaggesca, in quel
giro di anni, a cavallo dei due secoli, che vedono l'artista parallelamente impegnato in
San Luigi de' Francesi. Anche nell'Amor vincitore, che si ispira all'Omnia vincit amor di
virgiliana memoria, le allusioni colte sono sopraffatte dalla verità palpitante della
scena e dalla sfrontata monelleria del carnalissimo nudo di giovinetto. Come testimonia il
Sandrart (un artista tedesco che per alcuni anni fu al servizio di Vincenzo Giustiniani)
l'impatto del dipinto era intensificato a bella posta da una tendina verde scura, che
abitualmente copriva la tela, per poi essere sollevata allorché un visitatore si
avvicinava ad ammirare il quadro.
Quanto all'Incredulità di San Tommaso, è uno di quei dipinti in cui l'artista tocca uno
dei suoi più alti vertici di concisione drammatica, assurgendo a vero e proprio manifesto
della sua poetica, consistente nel catturare la realtà, cogliendola, per così dire, sul
fatto, sorprendendola in flagrante. Caravaggio offre al nostro senso della vista la
corposa, calda verità delle sensazioni tattili, mettendo anche noi, in un certo senso,
nella dubitosa condizione di San Tommaso, cui è consentito di [ab]toccare con mano[bb].
Nell'Incredulità anche il taglio ravvicinato della scena, che ingigantisce le figure, ci
risucchia vicino a loro, fin quasi a farci entrare nel quadro. Con l'Incoronazione di
spine di Vienna, e soprattutto con il San Girolamo penitente dell'abbazia di Montserrat,
le cui misure coincidono perfettamente con quelle del quadro di ugual soggetto descritto
dall'inventario Giustiniani del 1638, giungiamo a ridosso della precipitosa e definitiva
fuga dell'artista da Roma. Non siamo ancora alla febbrile concitazione esecutiva degli
ultimi anni, ma già si intravede, nell'incalzare del buio e nel grumoso addensarsi della
materia pittorica, quella frenesia stilistica ed esistenziale che accompagneranno
l'ultima, suprema e sconvolgente stagione del pittore, incalzato dagli eventi, braccato
dagli sbirri e in fuga, forse, anche da se stesso.
Incredulità di San Tommaso - Caravaggio
Il tema della incredulità di S. Tommaso (Vangelo di Giovanni, XX, 24-29) era nodale negli
anni della Riforma e della Controriforma; era lì racchiuso ed esemplificato il grande
problema della verità rivelata, del credere per fede, e della necessità, per l'uomo
incredulo, di toccare con mano l'ineffabile. Nell'episodio, entrato nel lessico quotidiano
per definire chi si arrende solo alla realtà tangibile, è implicito un altro aspetto di
fondamentale importanza, ossia la misericordia, la comprensione di Cristo verso chi non sa
trovare nel proprio animo la forza di credere per fede; Cristo implicitamente perdona
Tommaso e gli offre la piaga del suo costato che l'apostolo aveva dichiarato polemicamente
agli altri apostoli di voler toccare, per credere che Gesù fosse veramente risorto, e
quindi per non dubitare della vita eterna: Gesù, che aveva detto "noli me
tangere" alla Maddalena, invita Tommaso al contatto, pur dichiarando dopo "Beati
quelli che pur non avendo visto, crederanno" e negando così il valore dei sensi.
Sovente, nei Vangeli, vi sono allusioni agli animi semplici che accettano di credere senza
chiedere prove; Tommaso risulta essere più colto degli altri apostoli, figura di
intellettuale problematico, che dubita e pretende conferme. Le implicazioni dell'episodio
evangelico e lo spessore dei suoi significati sembrano ben compresi da Caravaggio, che
affronta l'iconografia in modo innovativo. C'è un precedente in una incisione di Dürer,
nella serie La Piccola Passione (1509 circa), dove appare Cristo che, a figura intera,
contornato dagli apostoli, con la sinistra indica il cielo e con la destra guida la mano
di Tommaso (FRIEDLÄNDER [1955]); ma la concezione nordica del Cristo-uomo dei dolori,
ieratico, a figura intera di Dürer, non ha nulla da spartire con l'umanissimo Cristo di
Caravaggio, che delicatamente scosta il sudario in cui è avvolto, per consentire al dito
di Tommaso di entrare nella piaga; la mano di Gesù guida quella dell'apostolo, la bocca
sembra accennare una impercettibile smorfia di dolore, mentre lo sguardo accompagna il
gesto, così come S. Pietro, nel laterale della cappella Cerasi, guarda il chiodo appena
confitto nella sua mano sinistra. C'è un divario cronologico tra la foggia della veste di
Cristo, drappeggiata come la toga di un antico filosofo, e quelle degli apostoli, non
diversamente dall'anacronismo che si coglie nella Vocazione di S. Matteo (cappella
Contarelli) fra l'abbigliamento alla moderna degli astanti e quello di Cristo e S. Pietro:
un evidente mezzo per accrescere la sacralità fuori dal tempo dell'apparizione, e la
attualità vivente dei destinatari del suo messaggio. Le fronti aggrottate dei tre
apostoli curvi davanti alla rivelazione della piaga, con gli occhi intenti, la forma a
spirale della composizione e il taglio a mezza figura e poco più, tipico in Caravaggio
per i formati orizzontali, i cosiddetti "sopraporta", pongono l'osservatore a
diretto contatto con quanto accade nel dipinto e gli danno la sensazione dell'attimo
sospeso. Il chiarore che emana dal corpo di Cristo, un corpo terreno eppure metafisico, la
luce che viene da sinistra, batte sulle fronti degli apostoli e rischiara i toni
marrone-rossastro delle loro vesti, danno consistenza monumentale alle quattro figure
strettamente addossate fra loro; l'essenzialità con cui il dipinto è costruito, la
rinuncia assoluta a ogni particolare superfluo lo rendono capitale nella evoluzione di
Caravaggio e nella storiografia artistica. Per una storia degli studi su di esso nel
Novecento, dobbiamo partire da Marangoni, che individuava nella buona copia conservata a
Firenze, Uffizi, una testimonianza antica del dipinto Giustiniani (MARANGONI [1922b], pp.
792-795) descritto da Bellori (BELLORI [1672], p. 207). Subito dopo Voss segnalava che
l'esemplare Giustiniani, acquistato a Parigi (1815) dal re di Prussia, si trovava in
Germania (VOSS [1923], pp. 94-95; VOSS [1924a], pp. 79, 442); Voss menzionava una lista
redatta nel 1829 che separava i quadri Giustiniani più belli da quelli ritenuti meno
degni di figurare nelle raccolte reali e messi a disposizione dell'Intendenza; questa
lista, intitolata Verzeichniss derjenigen Gemälde der ehemaligen Giustinianischen Galerie
[...] welche als für das Museum nicht geeignet zur Disposition der Königlichen
Hofeignung e conservata a Berlino, Archiv der Akademie der Künste, PrAdK 185, ff. 9-11,
è stata poi preziosa per riscontrare la collocazione attuale di alcuni dipinti (DANESI
SQUARZINA [1997]), grazie anche agli ottimi studi di Gerd Bartoschek (infra). Dei cinque
Caravaggio acquistati, solo Amore vincitore, Ritratto di Fillide e S. Matteo con l'Angelo
(perduto) venivano ammessi a Berlino; l'Incredulità di S. Tommaso e Cristo nell'orto con
gli apostoli venivano posti in subordine, e inviati, il primo nel castello di
Charlottenburg, il secondo (perduto) a Erfurt. Dopo gli scritti di Voss il quadro non fu
accolto unanimemente come originale; Longhi e Wagner (LONGHI [1943] pp. 12, 39 nota 25;
WAGNER [1958], p. 188) ritenevano si trattasse di una copia; Venturi (VENTURI [1951], pp.
52, 61) redigeva la scheda della tela di Firenze, Uffizi, come copia di originale perduto
con riferimento a Marangoni (MARANGONI [1922b]), e dava notizia della tela Giustiniani a
Potsdam segnalata da Voss (VOSS [1923]), citando Baglione, Bellori, nonché Bizoni (BIZONI
[1606, ed. 1942], p. 200), per la copia presso Orazio del Negro; riferiva inoltre che la
tesi di Voss non era stata accettata da Longhi e si asteneva dal prendere una posizione
personale. A dire il vero, proprio sull'Incredulità, si erano creati aspri conflitti
all'interno della Commissione per la scelta delle opere da esporre alla grande mostra
milanese di Caravaggio (MILANO [1951]), di cui facevano parte sia Longhi sia Venturi.
Longhi intendeva esporre la Incredulità di S. Tommaso, già attribuita a Rodriguez e
conservata a Messina, Museo Nazionale, inv. 424, con una nuova attribuzione a Caravaggio.
Il conflitto, che ben emerge da un fitto carteggio conservato nell'archivio di Lionello
Venturi (Dipartimento di Storia dell'Arte, Università la Sapienza, Roma) fu risolto con
un compromesso. Il dipinto di Rodriguez non venne esposto, con la motivazione che il
restauro non era ancora compiuto e che lo stato di conservazione non consentiva la
presentazione in mostra (in realtà un verbale del Consiglio Tecnico dell'Istituto
Centrale del Restauro, in data 5 aprile 1951, ci dice che il restauro era ultimato). Nella
scheda (MILANO [1951], p. 25 n. 25) veniva espressa l'attribuzione a Caravaggio, con la
precisazione che essa era formulata da Longhi, il quale, nel medesimo catalogo, toglieva a
Rodriguez e dava al Merisi anche la Cena in Emmaus dello stesso Museo di Messina. Fra le
illustrazioni (MILANO [1951], fig. 25) veniva inserito un piccolo particolare della
Incredulità di Messina recante in didascalia il nome di Caravaggio. Veniva inoltre
esposta e pubblicata (fig. 53, scheda 54), come copia, la tela di Firenze, Uffizi,
segnalata da Marangoni; e lì si dava conto della Incredulità di Potsdam, segnalata da
Voss molti anni prima, precisando però come Longhi escludesse che quello fosse
l'originale (LONGHI [1943], pp. 12-13). È evidente la contraddizione implicita fra la
scheda 54 e la scheda 25, frutto di un compromesso fra opposti intendimenti: se il dipinto
degli Uffizi era una copia della Incredulità di Caravaggio, l'Incredulità di Messina,
già attribuita a Rodriguez, non poteva essere l'originale di Caravaggio descritto da
Baglione e Bellori. L'attribuzione longhiana del Rodriguez a Caravaggio non ha avuto
seguito; tuttavia è utile ricostruire gli antefatti al catalogo del 1951 attraverso le
numerose lettere conservate, come si è detto, nell'archivio di Lionello Venturi. Esse
trovano un sintetico riepilogo, per quanto concerne l'Incredulità, in quella del 20
maggio 1951 di Guglielmo Pacchioni, Soprintendente alla Galleria di Firenze, che riferisce
a Lionello Venturi di un apposito viaggio di Fernanda Wittgens a Firenze per comporre il
conflitto alla vigilia della stampa del catalogo: Longhi aveva accettato che
l'Incredulità di Messina restasse in catalogo come un Rodriguez, con quel commento che
lui stesso avesse voluto per sostenerne la sua attribuzione a Caravaggio; Pacchioni
lamentava però che l'accordo non era stato interamente rispettato. Indubbiamente gli
studiosi non riuscivano a prendere coscienza dell'importanza della Incredulità di S.
Tommaso acquistata dal re di Prussia, nonostante la segnalazione di Voss, per
l'impossibilità di esaminarla direttamente e non solo in fotografia (MAHON [1951], p. 228
nota 56); va sottolineato che nel 1945 il dipinto fu portato in Unione Sovietica, e
restituito a Potsdam solo nel 1958; non a caso Friedländer, che lo riteneva l'originale e
lo datava coi laterali Contarelli, aveva ritenuto che fosse disperso (FRIEDLÄNDER [1955],
p. 61). Il ritrovamento dell'inventario redatto alla morte di Vincenzo Giustiniani nel
1638 (SALERNO [1960]), fu l'argomento decisivo a favore dell'autenticità del quadro,
attraverso l'autorità del committente. Passò così in secondo piano quanto scriveva
Baglione circa l'esistenza di una Incredulità di S. Tommaso presso i Mattei a Roma. La
pubblicazione degli inventari e dei pagamenti Mattei portò ulteriore chiarezza
(CAPPELLETTI-TESTA [1990], p. 243, nota 82; vedi anche Gregori in FIRENZE-ROMA
[1991-1992]). Le due studiose riferiscono che secondo Gaspare Celio i Caravaggio in
collezione Mattei erano solo tre (CELIO [1638], p. 134) e segnalano un quadro di questo
soggetto pagato a Prospero Orsi. Una copia dell'Incredulità di S. Tommaso (cm 95 ¥ 127)
è stata venduta presso la casa d'aste Antonina, familiare ai discendenti dei Mattei; il
dipinto, ora a Roma, collezione privata, presenta una cornice del Settecento con incise le
iniziali "G.M."; potrebbe trattarsi di Giuseppe Mattei, che alla fine del
Settecento fece eseguire nuove cornici per alcuni dipinti Mattei, fra cui la Presa di
Cristo di Caravaggio oggi a Dublino, National Gallery of Scotland (CAPPELLETTI-TESTA
[1994], pp. 83, 88, nota 41). Alla luce anche di questo è prudente ritenere che
l'esemplare Mattei fosse semplicemente una buona replica. Fra le fonti che ci descrivono
il dipinto è importante quanto scrive Sandrart circa la resa naturalistica (SANDRART
[1675, ed. 1925], p. 276); Silos volge in morbosità barocca il rigore caravaggesco:
"Illo / Vulnere nectareo roscida mella bibit" (SILOS [1673], p. 92. Epigramma
CLXV). L'Orazio del Negro presso il quale Vincenzo Giustiniani, durante il suo viaggio del
1606 (BIZONI [1606 ed. 1995], p. 141) vede "una copia del S. Tomaso del signor
Vincenzo, di Caravaggio", altri non è che un membro di un ramo della famiglia
Giustiniani (DANESI SQUARZINA [1994], p. 386, nota 33). Strozzi eseguì una Incredulità
di S. Tommaso palesemente influenzata da quella di Caravaggio; è probabile l'avesse vista
presso Orazio del Negro, oppure a Roma, in palazzo Giustiniani, dove ebbe modo di vedere e
imitare la Carità di Luca Cambiaso (vedi scheda infra); Pesenti ricorda la copia
dell'Incredulità presso Orazio del Negro e concorda sull'ipotesi di un viaggio a Roma
dello Strozzi (PESENTI [1992], pp. 74-77). Malvasia elenca copie esistenti a Bologna,
collezione Lambertini e Legnani, menziona una copia che Tiarini fa eseguire dal proprio
figlio e copie eseguite da Lionello Spada e Lorenzo Garbieri (MALVASIA [1678-1769, ed.
1841-1844], vol. II, pp. 75, 138, 217); la fitta circolazione può far pensare che il
cardinale Benedetto portasse con sé il dipinto come arredo della sua dimora durante la
legazione bolognese (1606-1611); Perini ritiene che la copia di casa Lambertini abbia
avuto un peso sulla riforma pittorica dei Carracci (PERINI [1995], p. 200). Un'altra
replica dell'Incredulità figura nell'inventario di Caterina Giustiniani Savelli (DANESI
SQUARZINA [2001]), Scannelli menziona una probabile copia nella Galleria Ludovisi
(SCANNELLI [1657]). L'importanza che ebbe il dipinto per i contemporanei è attestata
dalle numerosissime copie (MOIR [1976], pp. 89-90, 127, note 190-192; CINOTTI [1983], pp.
489-490). Cinotti (CINOTTI-DELL'ACQUA [1971]) è favorevole all'autografia; Calvesi
(CALVESI [1971]) vede nel dipinto un'allegoria della Chiesa attraverso la certezza della
Resurrezione di Cristo; Calvesi (CALVESI [1990], p. 363) vede nella struttura della
composizione un simbolo della croce; Hibbard (HIBBARD [1983]) ne rileva la fusione di
classicismo e anticlassicismo; Marini (MARINI [1989], p. 424) sottolinea che la
composizione, serrata intorno a un fulcro, torna in opere più tarde. È merito di Mina
Gregori (FIRENZE-ROMA [1991-1992]) aver consentito un riesame complessivo del fondamentale
dipinto e aver promosso, profittando della presenza del dipinto a Roma per l'esposizione,
indagini radiografiche e riflettografiche (vedi il rendiconto, con contributi di E.
Acanfora, R. Lapucci, G. Papi, S. Sciuti, in FIRENZE [1992]). Il quadro è in ottime
condizioni; forse ebbe un rifodero a Parigi, prima della vendita. I musei di Potsdam sono
contrari ai restauri che tolgono le vecchie vernici; il dipinto viene periodicamente
controllato e ravvivato ma non sverniciato. Per questo motivo si presenta ingiallito,
tuttavia la sua lettura non è offuscata; la prudenza dei restauratori non è criticabile.
Il modello usato per l'apostolo al centro, sul retro, è lo stesso del S. Pietro in primo
piano nel Cristo nell'orto (già Erfurt, opera perduta) e dello staffiere nella
Conversione di S. Paolo, cappella Cerasi; anche il S. Gerolamo Giustiniani presenta una
forte affinità di lineamenti; la testa dell'apostolo al centro della Incredulità era
forse in prima stesura più calva; sembra che un po' di capelli siano stati aggiunti in un
ripensamento dell'artista. Secondo Mina Gregori la datazione intorno al 1600-1601 sembra
essere la più plausibile, a seguito dei confronti effettuati con altre opere come la Cena
in Emmaus già in collezione Mattei (Gregori in FIRENZE-ROMA [1991-1992], p. 376). (Silvia
Danesi Squarzina)
S. Gerolamo penitente - Caravaggio
La provenienza Giustiniani non è indiscussa: un S. Girolamo appare
nell'inventario del cardinale Benedetto del 1621 e in quello di Vincenzo del 1638, con
identiche dimensioni. Nell'inventario del 1793 è forse individuabile, anche se il diverso
valore dei palmi rende il confronto incerto, in una descrizione che indica come autore lo
Spagnoletto (inv. 1793, I, n. 58). Quattro S. Girolamo appaiono nell'inventario del 1802,
senza misure, tre come Spagnoletto (nn. 86, 152, 204) e uno come Caravaggio (n. 174). È
da notare che proprio l'attribuzione allo Spagnoletto favorì, nel 1915, l'acquisto al
prezzo di 65 lire da parte dell'Abbazia spagnola di Montserrat, interessata ad un artista
iberico; nello stesso periodo entrano nelle collezioni dei religiosi due S. Girolamo
riferiti alla scuola del Ribera (ANALECTA MONTSERRATENSIA [1917], p. 339; BARROERO [1992],
pp. 30-33). Un altro elemento di dubbio viene dalla descrizione offerta dall'epigramma del
Silos "et saxo tundere corda gravi": tuttavia la mano del Santo, che sembra
stringere qualcosa, e la posa meditativa possono avere indotto in errore il Silos. Fu
Maurizio Marini, peraltro, a proporre l'identificazione del S. Girolamo Giustiniani nel
quadro di Montserrat, sottolineando la coincidenza precisa delle dimensioni e suggerendo
la presenza di una pietra nella mano, in realtà non ravvisabile. LONGHI [1943] rilevava
in questo dipinto la mancanza di rifinitura. Il linguaggio scarno e assolutamente privo di
compiacimenti può trovare una rispondenza nella committenza di Benedetto Giustiniani,
più attento agli aspetti dottrinali che a quelli formali. Una analoga asprezza si
riscontra nel perduto Cristo nell'orto degli ulivi, che apparteneva al cardinale, mentre
Christiansen sottolinea l'estrema raffinatezza di rifiniture dei dipinti di Caravaggio
destinati a Vincenzo, come una precisa richiesta di quest'ultimo (CHRISTIANSEN [1986], p.
440). Nel 1914 il dipinto si trovava a Roma in collezione Magni e anche questo non è in
contraddizione con la dispersione della collezione Giustiniani che si protrasse per vari
rivoli e vendite fino alla fine dell'Ottocento. Fu presso Magni che lo vide Longhi,
avanzando subito una attribuzione a Caravaggio, che venne formulata per iscritto nel 1943
con datazione al 1603 (LONGHI [1943], p. 13) ed ebbe come seguito la presentazione
dell'opera alla grande mostra di Milano (MILANO [1951], p. 29, n. 34) con una datazione
agli ultimi anni del soggiorno romano (opinione condivisa da AINAUD DE LASARTE [1947], pp.
395-396); fu Ainaud de Lasarte a riconoscerlo come il S. Girolamo già Magni fra i dipinti
dell'Abbazia benedettina. L'autografia del dipinto è stata accolta quasi unanimemente
(VENTURI [1951], pp. 27, 29, 56, che ne esclude la corrispondenza con il "S. Gerolamo
con un teschio nella meditazione della morte", conservato nel Palazzo del Gran
Maestro a Malta e menzionato dal BELLORI [1672, ed. 1976], p. 227; HINKS [1953], pp. 71,
112; BAUMGART [1955], pp. 35, 103; NICOLSON [1979], p. 33; CINOTTI [1983], p. 466; GREGORI
[1985], pp. 298-300); si sono opposti ARSLAN [1951], p. 446; VOSS [1951], p. 168;
FRIEDLÄNDER [1955], p. 204; WAGNER [1958], p. 232; ROSSI [1973], p. 89; HIBBARD [1983],
p. 320). MOIR [1976], pp. 119, 161, propone addirittura il nome di Ribera giovane ma, a
nostro avviso, i punti di contatto, ossia le mani gonfie e l'epidermide tesa e raggrinzita
(BERENSON [1951], p. 39 lodò la resa del nudo) e la capacità di raffigurare la
vecchiaia, sono una particolarità del Merisi che influenzerà il Ribera. Non è forse
casuale la somiglianza fisiognomica del modello qui usato dall'artista con quelli di altri
dipinti Giustiniani: la figura centrale sullo sfondo dell'Incredulità di S. Tommaso e il
S. Pietro del Cristo nell'orto degli ulivi. La stesura sommaria e corsiva induce a portare
la datazione verso gli ultimi anni del soggiorno romano. Su questo è d'accordo GREGORI
[1985], pp. 298-300, n. 84, che esprime tuttavia dei dubbi in merito alla provenienza
Giustiniani del dipinto. A giudizio della studiosa, la posa del Santo sarebbe la stessa
del S. Giovanni Battista di Kansas City. Dopo la presentazione alla mostra NAPOLI-NEW YORK
1985 si sono alzate voci contrarie alla autografia, PREVITALI [1985] p. 79 nota 21, VAN
TUYLL [1985] p. 487, CINOTTI [1991] lo elenca invece con sicurezza fra le opere certe.
Come giustamente scrive BARROERO [1992], p. 33, non è possibile ricacciare il S. Girolamo
nel novero delle copie o delle imitazioni "senza provare una sorta di
lacerazione". BENEDETTI vede nell'atteggiamento del Santo la precisa ripresa di una
statua della collezione Giustiniani. Vedi inoltre la scheda di G. Papi in ROMA [1992].
L'iconografia del Santo, che ricorre più volte nella collezione Giustiniani, adombra un
interesse culturale per il suo valore di esegeta delle Scritture e per il suo esempio di
ascesi. CHRISTIANSEN [1986], p. 440, ritiene la tecnica del dipinto diversa da quella che
ci è nota per Caravaggio e rileva l'assenza dei segni tracciati col manico del pennello
sulla superficie del colore come guida della composizione; SCHNEIDER [1987], p. 120, nota
le caratteristiche pennellate vibrate con foga da Caravaggio nella fase dell'abbozzo, nel
panno bianco che avvolge il ventre e il gomito del Santo. Esami radiografici e a
infrarossi effettuati dal gruppo coordinato da S. Sciuti, e promossi da Mina Gregori in
occasione della mostra FIRENZE-ROMA [1991-1992] hanno rivelato pentimenti nel teschio
originariamente ruotato in maniera differente; sembrerebbe, a nostro avviso, che,
modificandone la posizione, Caravaggio abbia voluto sottolineare la somiglianza-identità
con la testa ascetica e scarnita del Santo, peraltro già puntualizzata da LONGHI [1952],
p. 41; l'incidenza della luce sottolinea tale analogia. La scheda tecnica di Roberta
Lapucci in SALONICCO [1997], pp. 110-113, evidenzia una stesura pittorica ricca di
affinità con altre opere certe del Merisi, come la zona scura degli occhi, ottenuta
risparmiando il tono del fondo, ovvero l'uso della biacca in tratti densi per le rughe
della fronte, la pratica di dipingere le forme anatomiche, sovrapponendo in seguito ad
esse i panneggi delle vesti; anche la presenza del cinabro negli incarnati, e nelle parti
in luce del manto di S. Girolamo, rilevata attraverso la fluorescenza dei raggi X (GREGORI
[1996], p. 69), trova riscontro in altri dipinti di Caravaggio. (Silvia Danesi Squarzina)
Incoronazione di spine - Caravaggio
Il recente ritrovamento di un documento sinora sconosciuto presso l'Archivio di Stato di
Vienna (Haus-Hof und Staatsarchiv/HHSTA, Oberstkämmereramt, Kasten 81 B, n. 2029 ex 1810)
fornisce una certezza definitiva in merito all'origine del dipinto (proveniente, come
presunto da tempo, dalla collezione del marchese Vincenzo Giustiniani) e conferma pertanto
la sua identificazione con l'Incoronazione di spine di Caravaggio descritta
nell'inventario del 1638 (SALERNO [1960], p. 135, II, n. 3), nonché in SILOS ([1673], p.
88) e menzionata dal BELLORI ([1672, ed. 1976], p. 222). L'ambasciatore imperiale presso
la Santa Sede barone Ludwig von Lebzeltern (1774-1854), intimo del papa costretto in
seguito agli accadimenti politici del 1809 e alla cattura e allontanamento di Pio VII da
Roma a lasciare la sua carica venendo addirittura imprigionato prima della precipitosa
partenza, scrive l'8 febbraio 1810, poco dopo l'arrivo a Vienna, all'Obersthofmeister
conte Wrbna per informarlo dell'acquisto di alcuni dipinti per le collezioni imperiali.
Lebzeltern, diplomatico di spicco della corte imperiale austriaca nei primi decenni
dell'Ottocento (rivestì cariche a Lisbona, Madrid, Roma, in Svizzera, a San Pietroburgo e
Napoli, dove morì, vedi ÖSTERREICHISCHES BIOGRAPHISCHES LEXIKON [1957-], 1972, vol. V,
p. 69), era un entusiasta cultore d'arte. Tanto entusiasta che la sua missiva suona in
alcuni passi come un memoriale sul ruolo svolto dall'arte in uno Stato moderno. Dopo aver
ringraziato l'imperatore (Francesco I, imperatore d'Austria dal 1804) per aver accettato
il dono dell'Annunciazione di Anton Raphael Mengs (evidentemente proveniente dall'eredità
del figlio di Mengs, Alberico, morto nel 1808), di cui Lebzeltern era entrato in possesso
(Vienna, KHM, GG, inv. 1613: RÖTTGEN [1999], vol. I, n. 10), spiega che per quell'opera e
per una tela raffigurante la "Resurrezione del Signore [...] ébauchée aux premiers
traits", sempre di Mengs, da egli destinata alla k.k. Kunstakademie di Vienna, erano
già state fabbricate le casse per il trasporto a Vienna, reso poi impossibile dalla
situazione politica e dalla sua precipitosa partenza. Riferisce quindi l'acquisto di altri
tre dipinti (acquisizioni di cui era già stato incaricato in termini generali
dall'imperatore nel 1808 e per cui aveva già ricevuto dei denari, ENGERTH [1886], p. 306,
doc. nn. 359, 360). Si tratta della Madonna con i SS. Antonio e Giacomo di Lanfranco
(Vienna, KHM, GG, inv. 223: proveniente dalla cappella Simonelli, nella chiesa di S. Marta
al Vaticano, abbattuta nel 1930; Schleier in ROMA [2000], n. XII.3), per la quale
Lebzeltern (che non indica la provenienza della pala) rimanda alla menzione del dipinto
nella biografia di Lanfranco dicendo che i connoisseurs lo ascrivono ad Agostino Carracci.
Si tratta poi del "bel Albano, c'est la fameuse Samaritaine du Prince
Giustiniani": Lebzeltern scrive che nonostante esso non sia in buono stato i suoi
consiglieri (Gaspare) Landi e (Antonio) Canova (quest'ultimo raccomandato all'ambasciatore
come esperto d'arte da Heinrich Füger, direttore della galleria viennese e pittore, che
evidentemente diffidava della competenza artistica di Lebzeltern: ibid., p. 306, doc. n.
359) hanno stimato a 1000 piastre il dipinto, che egli ha affidato al celebre restauratore
(Pietro) Palmaroli (riguardo a Palmaroli, successivamente famigerato per i restauri
eseguiti nella pinacoteca di Dresda vedi CONTI [1988], sub indice); in Palmaroli
Lebzeltern loda l'inventore dello "strappo", ovvero del distacco dalla parete e
del trasferimento su tela degli affreschi, scrivendo che per sole 100 piastre questi
(Palmaroli) fa raddoppiare il valore del dipinto, da lui (Lebzeltern) pagato solo 350
piastre (Vienna, KHM, GG, inv. 2698; SALERNO [1960], p. 102, n. 150; PUGLISI [1999], pp.
130 e ss., n. 40); si tratta infine del dipinto qui esposto: "Un Caravaggio,
représentant le Couronnement d'épines de N. S. (6. P. de hauteur sur 7 de largeur, demi
figures) d'une belle conservation, d'un grand effet et dont les Artistes si dessus nommés
(Landi e Canova) et le Chevalier (Vincenzo o Pietro) Camuccini ont été ravis. Ils l'ont
évalué à 800 Piastres, il ne m'en a couté que 200, graces aux besoins toujours
renaissants du Prince Giustiniani, qui a dissipé toute sa fortune à Paris et moyennant
quelques douceurs données à son Homme d'Affaire, dont il n'y a pour le compte de
l'Auguste Cour que 2 Ecus et demi". Lebzeltern scrive quindi che i dipinti menzionati
si trovano a Roma in mani sicure, e inoltre di avere appreso che la Consulta Romana ha
sancito un divieto di esportazione degli oggetti d'arte ma che per via delle lungaggini
della burocrazia romana non ha ancora potuto avere informazioni circa la forma sotto cui
tale divieto venga applicato. Evidentemente, si dovette rimandare il trasferimento dei
dipinti sino al 1816; in data 16 aprile 1816 il direttore della galleria imperiale
Heinrich Füger scrive nel suo Journal-Protocoll, tenuto a mo' di diario: [segue la
traduzione dal tedesco] "Arrivò una cassa con dipinti acquisiti dall'Ambasciatore
Signor Barone von Lebzeltern a Roma per la Galleria imperial-regia già nel 1810 ed ora,
terminate le guerre, qui inviati dallo stesso. Consistono nei seguenti pezzi: [...] (1.
Albani) 2.) Cristo coronato di spine di Michel Angelo di Caravaggio; mezze figure.
Acquistato per 200 piastre [...] (3. Lanfranco; 4. Mengs)", FRIMMEL [1909], p. 109.
All'Archivio di Stato non è stato possibile rinvenire né il rapporto del 19 aprile 1816
al k.k. Obristkämmereramt menzionato nel Journal-Protocoll né tre ulteriori documenti
relativi all'acquisizione. Lebzeltern quindi, non disdegnando di "ungere"
l'Homme d'Affaire, sfruttò le difficoltà finanziarie in cui versava il principe - non si
trattò certo di un caso isolato (cfr. p. ### - e acquisì prima del trasferimento della
collezione a Parigi due dipinti per la collezione imperiale. Nel 1638, il dipinto viene
descritto come segue: "Nella stanza grande de quadri antichi [...] 3. Un quadro
sopraporta con la Incoronat.ne de spine di Xpo N. Signore 4 mezze figure dipinto in tela
alto pal. 5 - [= 5?] lar. pal. 7 - [= 7?] di mano di Michelang.o da Caravaggio con sua
cornice profilata, e rabescata di oro". Sino al 1956, quando venne formulata la prima
ipotesi in tal senso, non si era mai pensato ad una provenienza del Cristo coronato di
spine dalla collezione Giustiniani. A partire da quella data, tale provenienza fu
sostenuta in numerose pubblicazioni soprattutto da M. Gregori, M. Marini e F. Bologna
certamente perché ritenevano il dipinto un originale di Caravaggio, nonostante il Salerno
nel 1960, in occasione della pubblicazione dell'inventario, avesse categoricamente escluso
tale identificazione, a causa tuttavia di un semplice errore di calcolo nella conversione
delle misure in palmi, 5H ¥ 7H (aveva dimenticato di aggiungere il mezzo palmo sia in
altezza che in larghezza), che lo indusse a ritenere il dipinto di Vienna troppo grande.
Le misure convertite che figurano nell'inventario sono cm 122,87 ¥ 167,55; le dimensioni
dell'originale sono di cm 127 ¥ 166 (palmo romano = cm 22,34). Non è questa la sede per
illustrare in extenso la storia dell'attribuzione del dipinto (cfr. bibliografia).
Probabilmente ci troviamo di fronte ad un classico esempio di come la provenienza di un
dipinto possa influenzarne, in questo caso negativamente, l'attribuzione. O si aveva forse
un concetto dello stile e dello sviluppo stilistico di Caravaggio difficilmente
conciliabile con questo dipinto? O forse l'opera presentava tratti stilistici in grado di
far dubitare di un'attribuzione al maestro anche rinomati conoscitori del Caravaggio quali
Roberto Longhi o Denis Mahon (oltre a numerosi altri studiosi di Caravaggio)? Ancora oggi
è degno di nota (oltre a costituire sino ai nostri giorni un tratto distintivo di
Caravaggio) che un fondamentale quanto classico criterio adottato per l'attribuzione di
un'opera d'arte, ovvero la convincente determinazione della sua collocazione cronologica
all'interno di una produzione di fatto molto ben documentata come quella del Caravaggio,
non possa essere applicato senza dare luogo a contraddizioni. Anche tra chi vedeva nel
dipinto un originale, la datazione oscillava tra un'esecuzione di poco precedente alla
cappella Contarelli a S. Luigi dei Francesi, quindi precedente al 1599 (MARINI [1987], pp.
174, 422, n. 35), un'esecuzione successiva alla cappella Cerasi a S. Maria del Popolo del
1601, quindi intorno al 1602-1605 (GREGORI [1991], p. 239), ed il primo periodo napoletano
intorno al 1606-1607 (cfr. Gregori in NEW YORK-NAPOLI [1985]; BOLOGNA [1991], pp. 333 e
ss.). Sono datazioni che coincidono grosso modo anche con le attribuzioni ad un seguace
romano di Caravaggio (Manfredi oppure copia romana dell'opera di Caravaggio) o con
l'ipotesi, formulata sin dall'inizio (per la prima volta da R. Longhi), che possibile
autore del dipinto fosse Caracciolo, vale a dire il più importante seguace del Maestro a
Napoli. Il dipinto di riferimento per quest'ultima ipotesi era naturalmente la
Flagellazione caravaggesca di S. Domenico a Napoli del 1607, la cui superficie tuttavia,
soprattutto dopo la pulitura recente, presenta un carattere del tutto diverso, assai più
aperto, ed il cui luminismo, con una struttura chiaroscurale che non lascia spazio a
compromessi, è da attribuirsi inequivocabilmente all'opera tarda. (In questo contesto si
deve accennare ad un problema caravaggesco tuttora irrisolto, che a sua volta porta a
Vienna: si tratta della posizione eccezionale rivestita dalla Madonna del Rosario
nell'opera napoletana, una problematica che esula tuttavia dalla presente nota). La
certezza ora acquisita circa la provenienza del dipinto dalla collezione Giustiniani
avvalora fortemente la stessa attribuzione dell'opera al maestro ed indubbiamente anche
una datazione al periodo romano, intorno al 1602-1605. In teoria, sarebbe naturalmente
ipotizzabile che Vincenzo Giustiniani avesse acquisito il dipinto a Napoli cioè dopo il
suo ritorno dal viaggio in Nord Europa compiuto nel 1606. Tuttavia, visto l'immediato
seguito romano di questa composizione sia con opere fedeli all'originale sia rovesciate in
Manfredi, Baburen o Valentin (BREJON DE LAVERGNÉE [1979], pp. 306-309), è più probabile
l'ipotesi che l'origine dell'opera sia romana. Pur con tutta l'imprevedibilità delle
oscillazioni stilistiche di Caravaggio, che annullano qualunque idea di sviluppo
stilistico lineare, probabilmente il dipinto è stato eseguito tra l'Incoronazione di
spine di Prato, la Presa di Cristo nell'orto della collezione Mattei (Dublino), il
Sacrificio di Isacco degli Uffizi e il Cristo nell'orto degli olivi (quasi sicuramente
andato distrutto a Berlino nel 1945), ma comunque prima della Madonna dei Palafrenieri
(Roma, Galleria Borghese). È possibile che Caravaggio abbia eseguito con pennellate più
aperte rispetto al resto la testa dei carnefici e che ne abbia dipinto in modo sommario le
spalle, che si differenziano nettamente dalla compattezza della superficie del torso di
Cristo (e della corazza del soldato) in primo piano, in funzione della collocazione
elevata del dipinto destinato a soprapporta. Anche il lieve "sotto in su" indica
che il pittore aveva previsto di posizionare in alto il dipinto. J. Müller Hofstede ha
richiamato l'attenzione, senza venir quasi recepito dagli studi caravaggeschi, su un
interessante collegamento, enucleando la somiglianza tra il dipinto di Vienna e la
concezione del Cristo coronato di spine di Rubens per S. Croce in Gerusalemme a Roma (oggi
a Grasse) sicuramente databile al 1601-1602, pur sempre commissionato da un personaggio
della statura dell'arciduca Alberto VII, governatore sovrano dei Paesi Bassi spagnoli.
All'epoca (MÜLLER HOFSTEDE [1971], p. 269), l'autore poteva partire dal presupposto che
l'opera qui esposta ricalcasse il perduto Cristo coronato di spine del Caravaggio in
collezione Giustiniani (una parentela ancor più spiccata con l'opera di Rubens può
essere ravvisata nel Cristo coronato di spine caravaggesco di Prato) e suppose che Rubens
conoscesse e si fosse ispirato all'originale della collezione Giustiniani, che pertanto
dovette datare al più tardi al 1601. Ma un'affinità ancor maggiore con l'opera della
collezione Giustiniani - nella postura, nel collo pressoché orizzontale del Cristo - la
si ritrova in un disegno di Rubens conservato a Braunschweig (BRAUNSCHWEIG [1999], n. 2),
sempre considerato un disegno preparatorio per il Cristo coronato di spine di S. Croce in
Gerusalemme (Grasse). Rubens potrebbe tuttavia averlo concepito anche in un momento
successivo, nell'ambito della preparazione di un Cristo coronato di spine non più
eseguito, ispirandosi per l'appunto al quadro qui esposto (e avendo naturalmente in mente
il dipinto di Tiziano per S. Maria delle Grazie di Milano, oggi al Louvre). Anche questa
connessione Rubens-Caravaggio avvalora l'ipotesi che il nostro dipinto abbia visto la luce
a Roma. Comune ad entrambi gli artisti a quell'epoca, agli inizi del secolo, è lo
spiccato interesse per la scultura classica (p.e. il Torso del Belvedere); per Caravaggio
cfr. anche Gregori in FIRENZE [1991], p. 208. (Wolfgang Prohaska)
La liberazione di S. Pietro dal carcere - Gerrit Van Honthorst
Il dipinto si trovava in origine nella collezione del cardinale Benedetto Giustiniani,
come ha recentemente dimostrato il rinvenimento dell’inventario post mortem dei suoi
beni, redatto nel 1621, nel quale compare citato come "Un quadro di San Pietro in
prigione destato dall’angelo con cornice indorata" (DANESI SQUARZINA [1997], p.
786); sebbene il documento non riporti né le misure né il nome dell’artista autore
del quadro è possibile identificare tale entrata d’inventario con quella successiva,
dell’inventario dei beni del marchese Vincenzo Giustiniani, stilato nel 1638, dove
compare "Un quadro sopraporto di San Pietro in Carcere con l’Angelo, che lo
viene a liberare finto di notte dipinto in tela, alta palmi 5 e H larg. 8 si crede di mano
di Gherardi con sua cornice rabbescata d’oro" (SALERNO [1960], p. 96); alla
morte di Benedetto, infatti, i suoi dipinti confluirono nella collezione del marchese
Vincenzo, suo fratello ed erede dei suoi beni. Benedetto, dunque, e non Vincenzo, come si
era ritenuto finora, fu il committente di questa tela che, tra tutte le opere eseguite
dall’artista olandese nel corso del suo soggiorno romano, è certamente quella che
risente più da vicino della lezione del Caravaggio. La composizione si svolge lungo la
diagonale luminosa tracciata dal raggio della luce divina che accompagna l’arrivo del
messaggero di Dio e rischiara la cella buia dove si svolge l’azione, producendo un
mirabile effetto di chiaroscuro. L’angelo è ritratto in piedi sulla soglia della
cella, con il braccio disteso verso Pietro e sembra colto nel momento in cui pronuncia le
parole "Alzati, in fretta", così come sono riportate negli Atti degli Apostoli;
Pietro, ancora seduto, con la mano sinistra si copre la fronte rugosa per proteggersi
dalla luce che, inaspettatamente, ha inondato l’angusta cella nella quale è
rinchiuso. Il gesto del braccio disteso dell’angelo, raffigurato nel momento preciso
in cui, spalancata la porta della prigione, spezza le catene che trattengono
l’apostolo, appare chiaramente mutuato da quello compiuto da Cristo per chiamare a
sé Matteo nella Vocazione di S. Matteo eseguita dal Merisi per la cappella Contarelli
nella chiesa di S. Luigi dei Francesi, così come similare appare l’effetto del
raggio di luce che sottolinea il compiersi del miracolo. A questa somiglianza formale,
notata per primo dallo Schneider (SCHNEIDER [1933], p. 134), si deve aggiungere, a mio
parere, anche una meditazione dell’artista olandese su un altro dipinto del
Caravaggio, quel Cristo nell’orto degli ulivi già a Berlino, originariamente
collocato proprio nello studio del cardinale Benedetto, come gli studi della Danesi
Squarzina hanno potuto dimostrare (DANESI SQUARZINA [1997], p. 773, inv. 1621, n. 176).
L’Honthorst sembra aver tratto ispirazione da questo dipinto almeno per il tipo di
drappeggio del manto rosso-bruno della figura di S. Pietro che appare strutturalmente
concepito come quello dello stesso apostolo classicamente atteggiato, posto in primo piano
nella perduta tela del Merisi. Questa precisa scelta dell’artista di adeguare la sua
pittura giovanile, formatasi in patria a contatto con il vigoroso tardo manierismo del suo
maestro Abraham Bloemaert, alla pittura del Caravaggio, deve essere stata guidata da
Benedetto, che deve aver esercitato un’influenza fondamentale nella sua formazione,
orientando le sue scelte artistiche e spingendolo a confrontarsi, oltre che con la lezione
caravaggesca, con quella "linea genovese luministica" (PAPI [1999]) che ha i
suoi punti guida nelle opere dei pittori Luca Cambiaso e Domenico Fiasella, ampiamente
rappresentati nelle collezioni di Benedetto e di Vincenzo Giustiniani, i cui echi ben si
colgono in opere romane quali il Cristo davanti al Gran Sacerdote Giustiniani o la
Natività degli Uffizi. Sull’autografia della Liberazione di S. Pietro dal carcere,
che è opera non firmata, si sono sempre trovati concordi tutti gli studiosi, mentre più
problematica è apparsa la sua cronologia che resta strettamente collegata alla
definizione della data dell’arrivo dell’artista olandese in Italia, non ancora
confermata da alcun dato documentario. Se, infatti, il Mancini nelle sue Considerazioni
sulla pittura (MANCINI [1617-1621, ed. 1956-1957], p. 258) afferma, in modo un po’
sibillino, che Gherardo "se ne venne in Italia - o Roma secondo il manoscritto della
Biblioteca Marciana di Venezia - in quei tempi ne quali la maniera del Caravaggio era
communemente seguitata", la consultazione dei Libri degli Stati delle Anime non aiuta
a dirimere la questione, poiché troppo comune era il nome Gherardo tra i componenti della
comunità fiamminga romana. Unico punto d’appoggio sicuro resta un disegno a penna
acquerellata, riproducente la Crocifissione di S. Pietro del Caravaggio, oggi conservato
presso la Nasjonalgalleriet di Oslo, firmato e datato 1616, che è la prima opera certa
dell’artista a Roma. Se Joachim von Sandrart nella sua Academia Nobilissima Artis
Pictoriae afferma che il pittore, del quale era stato allievo a Utrecht negli anni Venti,
abitò per i primi tempi del suo soggiorno in palazzo Giustiniani (SANDRART [1683]), la
presenza della Liberazione di S. Pietro nella collezione di Benedetto testimonia il fatto
che questo fu il primo dei dipinti eseguiti dall’artista per i Giustiniani.
L’interesse per Caravaggio sembra dunque concentrarsi intorno al 1616 e lascia
supporre quindi che questa sia la data più verosimile per l’esecuzione del dipinto.
Una datazione agli anni 1616-1618 è stata proposta sia dai curatori del catalogo della
mostra del 1986 (UTRECHT-BRAUNSCHWEIG [1986-1987]) che dallo Judson nella sua recentissima
monografia sull’artista (JUDSON-EKKART [1999], p. 93); solo il Papi (PAPI [1999], p.
134) ha ipotizzato una data leggermente più arretrata, tra il 1614 e il 1615, notando la
forte somiglianza dell’angelo che appare a S. Pietro con quello presente nel Cristo
nell’Orto degli Ulivi dell’Ermitage che lo studioso colloca in stretta sequenza
temporale con il quadro di Berlino. Un disegno conservato presso il Kupferstichkabinett di
Dresda (fig.1), individuato da Schneider (SCHNEIDER [1928], p. 114) è stato considerato
preparatorio al dipinto da Judson (BRAUNSCHWEIG [1987], pp. 111-112) che lo ritiene un
primo tentativo di elaborare il soggetto guardando al prototipo del Domenichino in S.
Pietro in Vincoli. È infine interessante notare che, negli anni Ottanta del Settecento,
il dipinto fu oggetto di un innovativo restauro da parte di Margherita Bernini che, su
incarico della principessa Cecilia Mahony Giustiniani, operò sulla tela usando un
procedimento basato sull’impiego della chiara d’uovo (CONTI [1988], p. 152);
secondo quanto è riportato nel "Giornale delle Belle Arti" del 1788, in questa
occasione fu sottoposto a tale procedimento conservativo, insieme con altre tele della
collezione, anche il Cristo davanti al Gran Sacerdote dello stesso autore. (Loredana
Lorizzo)
La lavanda dei piedi - Dirck Van Baburen
Per quasi un secolo (dal 1884 al marzo 1982) esposta in prestito a Wiesbaden, prima nel
Nassauerische Kunstverein, quindi nelle Städtische Gemäldesammlungen, dove è detta
erroneamente essere conservata nella riedizione dell’enciclopedia caravaggesca del
Nicolson (NICOLSON-VERTOVA [1990]), questa pietra miliare del caravaggismo può solo da
pochi anni essere giudicata e ispezionata con l’agio necessario nella sua -
collezionisticamente parlando - città adottiva. Da una prima, veloce, esplorazione,
emerge che la tela è stata foderata, ma ancora prima della vendita parigina del 1812. Sul
nuovo supporto, in basso a destra, è trascritta la sigla garante della provenienza
Giustiniani. I colpi di pennello che, a chi scrive, erano parsi delle incisure, ovvero dei
pro-memoria per l’esecutore in ordine alla sistemazione nello spazio delle figure,
secondo una metodologia adottata anche da Caravaggio, sono in realtà colpi di pennello
che profilano soprattutto (ma non esclusivamente) arti e volti dei protagonisti. Descritta
nell’inventario della collezione di Vincenzo Giustiniani, nel 1638, come "Un
quadro sopraporto grande, Christo che lava i piedi all’Apostoli dipinto in tela, alta
palmi 9 lar. 13 figure intiegre di mano di Theodoro fiamengo senza cornice" (SALERNO
[1960]), la vasta pittura, nonostante la specificazione onomastica (ma priva del
patronimico), ha sofferto di una un po’ tormentata, e palesemente non necessaria,
oscillazione attributiva. Se "Theodoro fiamengo" potrebbe non esclusivamente
corrispondere alla figura storica del Baburen (si sarebbe per esempio autorizzati, in
ambito naturalistico, a promuovere il non meno grande Van Loon), e se ci si deve arrendere
alle generalizzazioni del gusto che portano ad affiggere su ogni pittura dotata di
stimmate veristiche e di forte contrasto chiaroscurale l’etichetta
"Caravaggio" (DE COTTE [1690 circa, ed. 1960]; RAMHDOR [1787]), un sofisticato
sistema di relazioni stilistiche era già stato prodotto da Tommaso Conca nel 1802, quando
l’artista campano (in FILANGIERI DI CANDIDA [1902]) ben vedeva i nessi col celebre
Seppellimento in S. Pietro in Montorio e con l’ancora dibattuto Cristo fra i Dottori
nella Certosa di S. Martino a Napoli (Maestro del Giudizio di Salomone; Douffet..., ma non
certo Keihlau, come è stato recentemente proposto!). Parzialmente copiato in precedenza
dal francese Ango, che lo vide negli anni Sessanta del Settecento ancora in palazzo
Giustiniani, gonfiandolo a "Vandeik" e passato col Vasi (VASI [1804]) a
fregiarsi della paternità di un inesistente "Vanderstern" (al quale peraltro
era passata in dote anche la tela di S. Pietro in Montorio), il Delaroche (DELAROCHE
[1812]) per primo puntò sull’algido nome del francese Valentin, ovviamente imitato
dal Landon (LANDON [1812]) prima e dal Waagen (WAAGEN [1830]) poi e, ancora mezzo secolo
dopo, dal Parthey (PARTHEY [1864]), passando per le Verzeichnisse del 1841 e del 1860.
Bisognerà aspettare l’acume critico del Voss (VOSS [1924A]), subito seguito da
Longhi (LONGHI [1926]) e da von Schneider (SCHNEIDER [1933]), perché la Lavanda dei piedi
venga reintegrata al suo vero autore, non senza che, curiosamente, le penne del pavone
siano state indossate interlocutoriamente anche dal Van Bijlert nella Verzeichniss del
1886, con punto d’interrogazione e, ignara dell’appena pregresso avanzamento
critico, nella Verzeichniss del 1931. Spostandoci ora sul piano dello stile, non pare
negoziabile l’affermazione che la gran tela Giustiniani sia la più caravaggesca mai
dipinta dal suo seguace olandese, titolare nondimeno di un assai tenue catalogo, in
ragione anche della prematura morte, caduta, verosimilmente non molto più che trentenne,
nel 1624. È stato colto, come poco meno eversivo confronto con una realtà tutto fuor che
accomodata, o aulica, il rapporto che lega lo sguaiato apostolo in bilico, le gambe
parimenti accavallate, sul suo sgabello in primo piano a sinistra, al perduto prototipo
della prima versione del S. Matteo con l’Angelo del Caravaggio, destinato
all’altare della cappella Contarelli in S. Luigi dei Francesi, che, dopo il rifiuto,
era non a caso approdato nella raccolta del marchese Vincenzo Giustiniani, dove poté
essere facilmente studiato dal giovane olandese. Eppure, si è anche sottolineato come vi
sia un certo qual sforzo di bilanciamento compositivo nei due gruppi di figure, peraltro
incomunicanti, inframmezzati da tre supplementari presenze ingoiate dall’ombra, al
centro della composizione. Si era teso a immaginare, insomma, che fosse stato dato corso a
un adattamento caravaggesco da parte di un artista non ignaro di classicità di eloquio,
quale poteva ben essere il caso del giovane Baburen. Dunque un’opera giovanile
dell’artista, documentato ancora a Utrecht nel 1611 alla scuola del Moreelse, ma a
Roma nel 1619-1620, dove è censito nella parrocchia di S. Andrea delle Fratte, assieme al
collega David de Haen. È del tutto ovvio difatti che la più largamente nota commissione
romana - comune ai due soci nederlandesi - l’impresa di S. Pietro in Montorio, non
può non aver previsto una pregressa loro affermazione nel contesto romano. E forse un
simpatizzante in erba del Caravaggio poteva trovare anche senza eccessiva abbondanza di
curriculum un mentore entusiasta e disposto a vederlo in azione quale il marchese
Giustiniani. Tutto questo per giustificare - in assenza di prove - la posizione di chi
penserebbe di voler accusare un certo anticipo sul ciclo di S. Pietro in Montorio per il
quadro Giustiniani, intorno cioè alla metà del secondo decennio del secolo, o forse
anche un po’ prima. Dove puntello da non sottostimare è la fattura sgraziata e
sommaria di ambo gli arti visibili del protagonista, affogata tuttavia in un insieme di
possanza naturalistica che ha pochi eguali, pur in date già avanzate della breve
avventura figurativa dei caravaggeschi, e in contemporanea se non in anticipo su buona
parte dei napoletani (Ribera incluso), ma certo ben prima dei liguri (Assereto,
Borzone...) da pitture di questo genere clamorosamente ispirati. Prohaska (PROHASKA
[1978]) ha insistito, da una parte, sulla totale reticenza del Baburen ad avvalersi di una
scansione architettonica nella quale inscrivere i due gruppi principali e quello nel fondo
al centro, come quasi ingoiato dalla preparazione (abbandonandosi per conseguenza a
goffaggini compositive - magari anche a un’eccessiva forzatura espressiva di ognuno
dei personaggi - e comunque a una sorta di scena-fregio di memoria tardocinquecentesca),
dall’altra, - raccomandando soprattutto il confronto con la tela di pari soggetto di
Battistello alla Certosa di S. Martino - sull’impiego da parte dell’olandese di
una tavolozza bassa, ai limiti del monocromatico, giocata specialmente su bruni e grigi
sporchi, priva affatto di quelle accensioni cromatiche così specifiche del Caracciolo, ma
non meno del comune modello Caravaggio, lasciandosi però completamente conquistare dal
corrosivo imposto luministico. Una copia antica in formato ridotto (olio su tela, cm 124,5
´ 176) - forse di artista italiano (SLATKES [1965], p. 102) - è o era conservata nella
collezione romana dell’architetto Andrea Busiri Vici. Presentata come autografa,
accanto all’originale Giustiniani, alla mostra sui caravaggeschi nederlandesi
(UTRECHT-ANTWERPEN [1952]), la tela è stata immediatamente considerata copia dal Nicolson
(NICOLSON [1952]), senza però che tale giudizio pesasse sulla successiva presenza della
derivazione Busiri Vici (già presso il conte Carlo Brenciaglia a Roma, quindi presso
Grassi a Firenze) all’esposizione di pittura olandese secentesca tenuta a Roma nel
1954, dove in effetti il quadro fu dichiarato di mano del Baburen. Una copia del binomio
Cristo-S. Pietro in controparte può vedersi in un’acquatinta datata 1771
dall’Abbé di Saint-Non (FRAGMENTS... [1772], tav. 17), basata sul disegno di Jean
Robert Ango, artista francese contemporaneo tanto del Saint-Non che di Fragonard,
custodito nel Fogg Art Museum di Cambridge (inv. 1928.153), nel quale il frammento destro
della composizione di Baburen occupa la metà destra del foglio, mentre la sinistra deriva
dall’Elemosina di S. Lorenzo del Serodine, al tempo ancora in S. Lorenzo fuori le
Mura a Roma (oggi nel museo dell’abbazia di Casamari), con paternità spostate da un
lato verso Van Dyck, dall’altro verso la scuola di Guercino (Williams in
WASHINGTON-CAMBRIDGE [1978-1979], pp. 168-169, n.69). (Roberto Contini)
La cacciata dei mercanti dal tempio - Francesco Boneri
Il dipinto ha avuto un ruolo fondamentale nella ricostruzione del corpus di
Cecco; tramite il sonetto dedicatogli dal Silos nella sua Pinacotheca (SILOS [1673], p.
116), dove l'opera risulta essere di Checco del Caravaggio, Roberto Longhi nel 1943
(LONGHI [1943], pp. 26-27, 51) poté collegare al quadro una preziosa citazione del
pittore rintracciabile nel manoscritto del Mancini (MANCINI [1617-1621, ed. 1956-1957],
vol. I, p. 108) dedicato alle vite dei pittori a lui contemporanei. Così l'autore non
sarebbe stato altri che quel "Francesco detto Cecco del Caravaggio" che il
biografo inseriva nella scelta "schola" del Merisi, fino a quel momento rimasto
solo un nome, anzi un soprannome. Partendo dalle indicazioni stilistiche offerte dal
capolavoro berlinese, il grande studioso nella stessa occasione avrebbe poi riportato al
misterioso artista altri dipinti, che il tempo ha confermato: l'Amore al fonte di
collezione privata, la Resurrezione di Cristo dell'Art Institute di Chicago; il Suonatore
di flauto dell'Ashmolean Museum di Oxford. Era così costituito il nucleo primario, e
restituita l'identità del linguaggio di Cecco, la base solida da cui partire per
comprendere di più sul personaggio, per aggregare ancora altri dipinti, che ai giorni
nostri hanno raggiunto un numero che sfiora le due decine. Il brano del Silos è stato
molto importante, perché anche la successiva pubblicazione degli inventari Giustiniani da
parte del Salerno nel 1960 (SALERNO [1960], p. 143, n. 143), non avrebbe risolto la
questione, dal momento che l'inventario del 1638 non menzionava il nome dell'autore del
"quadro sopraporto grande con l'historia di Xpo che scaccia gl'Hebrei dal tempio
depinto in tela alt. Pal. 6 lar. 8 inc.a con cornice negra profilata e rabescata
d'oro"; ma ormai, a quel tempo, nessuno metteva più in dubbio l'identificazione di
Longhi, sulla base dei versi della Pinacotheca. Pochi anni fa Silvia Danesi Squarzina
(DANESI SQUARZINA [1998a], p. 118, n. 411) ha infine recuperato in un inventario
Giustiniani posteriore, del 18 novembre 1684, il nome mancante: "Un quadro sopraporto
grande con l'historia di Christo che scaccia l'Ebrei dal tempio dipinto in tela alta palmi
6 larga 8 si crede di mano di Checco del Caravaggio con cornice nera profilata e rabescata
d'oro". Col passare degli anni il nome sarebbe scomparso nella memoria della
collezione, al punto che alla vendita di Parigi (LANDON [1812], p. 21, fig. 7; DELAROCHE
[1812], n. 35) la Cacciata veniva catalogata come opera del Campino di Camerino (cioè di
Jean Ducamps di Cambrai); e nel 1924 il Voss (VOSS [1924a], pp. 99, 473) avrebbe evocato
l'ambito manfrediano, con qualche dettaglio che lo faceva pensare a Caroselli. Dal '43 la
storia è nota, ma lunga sarebbe stata la controversia sulla nazionalità del personaggio,
sulla sua cultura, per molto tempo confusa con quella di Louis Finson (e molti quadri di
Cecco erano in precedenza stati assegnati al pittore di Bruges). Circa dieci anni fa chi
scrive (PAPI [1991] e [1992]) ha risolto il problema dell'identità anagrafica di Cecco,
da riconoscere nel Francesco Buoneri (o Boneri), che fra il 1619 e il 1620 riceveva
pagamenti per avere eseguito la Resurrezione oggi a Chicago, commissionatagli da Piero
Guicciardini per la cappella di famiglia nella chiesa di S. Felicita a Firenze. Questa
scoperta mi portava ad avanzare nuove conclusioni: la possibilità di un'origine lombarda,
all'interno di una famiglia di artisti bergamaschi, i Boneri o Bonera di Alzano Lombardo,
non ultimi motivi la presenza di due dipinti di Cecco in una prestigiosa collezione
bergamasca costituitasi quasi interamente con dipinti di cultura locale e le evidenti
ascendenze savoldesche nella sua pittura. Un brano del diario del viaggio italiano di
Richard Symonds (1650 circa) pubblicato dal Wiemers (WIEMERS [1986], pp. 59-61),
riguardante l'Amore vincitore del Caravaggio, rivelava che a posare per la celeberrima
tela Giustiniani fu proprio Cecco, e indicava anche il rapporto molto stretto che il
ragazzo ebbe col Merisi, che verosimilmente lo ritrasse in altri suoi dipinti (la sua
fisionomia è sicuramente riconoscibile nel S. Giovanni Battista Capitolino, nel
Sacrificio d'Isacco degli Uffizi e nell'angelo della prima versione Cerasi della Caduta di
Saulo) e col quale ebbe un sodalizio inequivocabile (durato forse anche dopo la fuga da
Roma del Caravaggio nel maggio del 1606), a giudicare dalle parole del viaggiatore
inglese: si spiega così a mio avviso (PAPI [1996]) l'origine del soprannome Cecco del
Caravaggio e può venire ulteriormente confermata l'origine bergamasca di Francesco, che
fu garzone a Roma del pittore più grande della sua terra. Inoltre, l'aver posato per
l'Amore vincitore potrebbe essere una delle ragioni (non una delle minori a mio avviso)
per cui un quadro del Boneri (cioè la Cacciata), probabilmente in un tempo non troppo
lontano da quella posa, venisse commissionato, o almeno acquistato dal marchese Vincenzo
Giustiniani; si poté insomma stabilire, forse in anni assai precoci e tramite l'assoluta
stima per il Merisi, un rapporto fra il nobile e il giovane artista. La cronologia di
Cecco è legata soltanto a due date, quella già ricordata della Resurrezione Guicciardini
(1619-1620) e il 1613 (BERTOLOTTI [1876], p. 208), che lo vede collaboratore di Agostino
Tassi nel Casino Montalto a Villa Lante di Bagnaia (la sua mano è stata convincentemente
riconosciuta nell'affresco con la Famiglia di Dario presentata a Alessandro). Il fatto che
Francesco venga nominato distintamente dal Tassi in una deposizione processuale, rispetto
agli altri suoi aiuti (nessuno dei quali citato per nome), induce a credere che già a
quella data Cecco fosse pittore di qualche rilevanza e avesse una sua riconosciuta
individualità artistica. Considerando che egli posò sicuramente per quadri del Merisi
eseguiti nel 1603-1604, dove dimostra di essere appena adolescente, si potrebbe concludere
che egli sia nato fra il 1588 e il 1590. Con questi pochi dati è dunque azzardato
proporre una cronologia certa per la Cacciata Giustiniani; anni piuttosto precoci (1610 o
poco dopo) potrebbero essere giustificati dalla prepotente adesione caravaggesca
dell'opera. Che non debba essere trascorso molto tempo dall'impressione avuta dalle
clamorose novità del Merisi (che per Cecco del resto saranno stata pratica quotidiana)
sembra denunciarlo la similitudine compositiva col Martirio di S. Matteo: anche qui un
arretrare instabile di corpi urlanti, dalle espressioni terrorizzate, come
nell'accatastarsi senza equilibrio degli astanti nella grande tela di S. Luigi dei
Francesi, quasi spazzati via dalla raffica di orrore sprigionata dal martirio. E alcune
teste, alcune espressioni, la gestualità delle mani sventagliate, alcuni cappelli,
sembrano proprio rimandare a quel testo fondamentale per l'energia e per il dinamismo
delle scene di Cecco; ma anche certi brani, come il piede sollevato dell'uomo calvo
atterrato (una citazione del cosiddetto Schiavo di Ripa Grande?), segnano anche a livello
di ductus e di temperatura espressiva il massimo contatto del Boneri con la pittura del
suo maestro, tanto che questo piede sembra essere uscito dalla Madonna dei Pellegrini,
dalla Madonna dei Palafrenieri o dalla Madonna del Rosario. Certo il dipinto, se concepito
a una data così precoce da un ventenne di genio, conteneva in sé tanti spunti per il
linguaggio del caravaggismo del secondo decennio, e non solo per i compagni di strada di
Cecco: dal primo altare pagano con bassorilievo, usato come tavolo da gioco (elemento
ampiamente utilizzato dalla Manfrediana methodus e da Valentin in particolare), alla
sottigliezza bagnata con cui si dispongono le pieghe della veste di Cristo, che non
sfuggirà al Cavarozzi; e che dire del potente inserto architettonico, tagliato da una
luce fredda e razionale (che il Merisi non aveva mai ricercato), così classico nella
presentazione liscia e cristallina delle colonne scanalate da evocare non solo Poussin, ma
addirittura David. Dovrà infine essere sottolineata una scoperta compiuta proprio in
questa occasione. Non è mai stata finora rilevata (devo a Roberto Contini l'invito a
focalizzare l'attenzione sul particolare in questione) la scritta sul foglietto attaccato
alla costola del libro, che in primo piano viene calpestato dal mercante seduto sull'ara:
a una visione superficiale, in attesa di analisi scientifiche, non mi sembra illusorio
potervi leggere le prime lettere del cognome di Cecco, cioè BUON (o BON). (Gianni Papi)
Cristo resuscita il figlio della vedova di Naim - Domenico
Fiasella
Insieme al suo pendant, rappresentante Cristo risana il cieco nato (vedi scheda seguente),
il dipinto è menzionato nell'inventario post mortem di Vincenzo Giustiniani (1638) come
opera di Fiasella. Tuttavia, fonti successive testimoniano come ancora nel Settecento,
quando le due tele continuavano ad essere esposte nel palazzo presso S. Luigi dei
Francesi, tale attribuzione fosse caduta, dapprima in favore di Parmigianino (ROISECCO
[1765], vol. I, p. 568; DE LA LANDE [1769]) e quindi, in modo più comprensibile, in
favore di Ludovico Carracci (VASI [1794], pp. 275-276). Fu proprio come opere di Ludovico
che i due dipinti vennero proposti a Buchanan nel 1801 (BRIGSTOCKE [1982], p. 52). Essi
furono infine acquistati da Lucien Bonaparte, all'epoca residente presso palazzo
Giustiniani a Bassano Romano e poi trasferitosi prima presso palazzo Lancellotti e quindi,
nel 1806, presso palazzo Nunez, dove questo stesso dipinto risulta come opera di Agostino
Carracci accanto all'altro, considerato di mano di Ludovico (EDELEINE-BADIE [1997], pp.
40, 187-188). Buchanan acquistò entrambe le opere dal duca di Lucca in occasione
dell'asta del 1840 e le offrì senza successo alla National Gallery di Londra per un
prezzo di 11.000 sterline (BRIGSTOCKE [1982], p. 33). All'epoca del loro ultimo acquisto,
concluso dall'impresario circense John Ringling nel 1927 (che non aveva timore di
acquistare dipinti di grandi dimensioni), essi venivano attribuiti ad Annibale Carracci.
Nonostante la pervicace insistenza nel volerle associare al nome di un membro della
famiglia Carracci, nel 1960 le due tele furono finalmente restituite da Luigi Salerno al
loro effettivo autore, l'artista di origine ligure (SALERNO [1960]). Un dipinto datato
1608 e recante il monogramma dell'artista, il Vecchio suonatore e cortigiana (Trieste,
Pinacoteca del Lloyd Adriatico, cfr. DRIGO [1993], p. 147, fig. 3), nonché l'Assunzione
della Vergine e l'Annunciazione (Roccasecca, chiesa di S. Maria Assunta, cfr. CAPPELLETTI
[1998b], figg. 27, 29), commissionate nel 1613 da Valerio Massimi (figlio di una
Giustiniani), ci danno un'idea dell'attività romana di Fiasella. Tuttavia, sono proprio i
dipinti qui esposti a rappresentare al meglio lo stile monumentale sviluppato dall'artista
negli anni 1607-1615, prima del suo ritorno a Sarzana (egli è registrato negli Stati
d'anime della parrocchia di S. Lorenzo in Lucina nell'anno 1615, cfr. DONATI [1998], p.
36). In base a quanto riferito dal suo biografo Raffaello Soprani, sappiamo che prima di
recarsi a Roma Fiasella aveva studiato a Sarzana con suo padre, un rinomato argentiere, e
quindi a Genova con Giovan Battista Paggi. Dopo avere suscitato l'ammirazione di Guido
Reni con la sua Natività, l'artista fu invitato a collaborare con Passignano (attivo in
S. Andrea della Valle dal 1604 al 1616) e con il Cavalier d'Arpino (impegnato in S. Maria
Maggiore dal 1608 al 1610). I due dipinti qui esposti sono stati datati al 1615 circa e a
differenza di un gruppo di altre opere (da alcuni ritenuti una "serie"), in cui
i personaggi sembrano disporsi lungo la linea del primo piano (vedi scheda n. ###), il
centro coincide qui con una figura posta in diagonale, che retrocede e si collega con due
figure secondarie poste sullo sfondo della scena. Il giovane, ovvero il figlio della
vedova di Naim, osserva con stupore Cristo, che lo ha ricondotto alla vita e che tende il
braccio in segno di benedizione (Luca, 7,11-16). Questa figura, in particolare, fu molto
ammirata: "L'enfant est un chef d'oeuvre de vérité, surtout dans le mouvement qui
recommence sa vie et qu'il fallait deviner. C'est un trait de génie" (BONAPARTE
[1822]). Come afferma il suo biografo, Fiasella coltivò i propri contatti nell'ambiente
artistico romano. In questo stesso dipinto si può notare come l'interazione naturalistica
tra i personaggi può derivare da quanto appreso grazie alla collaborazione col
Passignano, mentre le proporzioni dilatate dell'uomo ricurvo in primo piano, in basso,
nonché lo studio anatomico e del movimento che essa suggerisce, risentono dello studio
dell'artista all'Accademia del Nudo a Roma e la sua conoscenza dei caravaggeschi e dei
Carracci. La cerchia dei suoi "contatti" romani poté includere Albani e
Lanfranco; il suo stile calligrafico potrebbe avere influenzato Francesco Albani al
momento della esecuzione del Cristo e la Samaritana per Giustiniani (Vienna,
Kunsthistorisches Museum), mentre la figura della donna che si scopre il volto sullo
sfondo del dipinto in esame, a destra, ricorda la donna del Giuda e Tamar di Giovanni
Lanfranco, dipinto nel 1615 per il cardinale Alessandro Peretti Montalto (Roma, Galleria
Nazionale d'Arte Antica). L'associazione ai Carracci è stata avanzata anche per un gruppo
di disegni di Fiasella conservati presso l'Art Institute di Chicago, attribuiti a
Ludovico. Uno di questi è uno studio per la figura femminile dello sfondo del Cristo
resuscita il figlio della vedova di Naim (fig. 2, inv. 1922.2273V, carboncino su carta
azzurra, cm 40,1 ¥ 26,8, segnalatomi gentilmente da L. Giles). Un altro disegno,
anch'esso un carboncino su carta azzurra, è uno studio per la figura posta dietro il
giovane (Genova, Palazzo Rosso, inv. 2219, cm 36 ¥ 23, cfr. Galassi in GENOVA [1990], n.
43). Lo stile accademico del disegno mostra chiaramente il modo in cui Fiasella fosse
solito studiare le figure in luce ed ombra prima di trasferirle sulla tela. Che a Genova
egli utilizzasse tali fogli è evidenziato dal recto del disegno di Palazzo Rosso, dove è
riconoscibile uno studio per una figura che egli dipinse ad affresco in palazzo Lomellini
Patrone, costruito tra il 1617 ed il 1619. Allo stesso modo del disegno di Chicago (anche
questo presenta sul recto uno schizzo di composizione, nel caso specifico per il David e
Golia) anch'esso fa parte di un gruppo di disegni che include studi per le figure della
pala d'altare, firmata e datata 1621, rappresentante la Barca di S. Pietro (Sestri
Ponente, S. Maria Assunta). Un versione più piccola di questo dipinto (fig. 1, collezione
privata, cm 74,7 ¥ 57,6), della stessa gamma cromatica e con proporzioni più strette e
allungate, suggerisce l'ipotesi che il progetto originario di Fiasella comprendesse un
numero maggiore di personaggi dietro la figura di Cristo ed uno sfondo architettonico
leggermente diverso. Una replica di questa stessa composizione (Inghilterra, Bowood House)
testimonia il successo riscontrato da questo dipinto in Inghilterra. Una volta divenuta
proprietà di Lucien Bonaparte, l'opera fu tradotta a stampa almeno tre volte: da Tommaso
Piroli nel 1812 (come Agostino Carracci), da Folo nel 1822 e da un artista ignoto, al n.
209 della collezione Bonaparte (cfr. EDELEINE BADIE [1997], p. 188). (Mary Newcome
Schleier)
Cristo risana il cieco nato - Domenico Fiasella
All'epoca in cui faceva parte della collezione di Lucien Bonaparte il dipinto veniva
attribuito a Ludovico Carracci; in particolare, se ne apprezzava lo sfondo "d'un
style austère et très bien composé" (BONAPARTE [1822], p. 111). Cristo, di una
monumentalità statuaria, è rappresentato in piedi, sulla destra, con le mani sugli occhi
del giovane inginocchiato di fronte a lui (Luca, 7, 21-22). Ricollegandosi idealmente alla
"guarigione" rappresentata nel dipinto pendant (anch'essa tratta da un passo del
Vangelo di Luca), discusso nella scheda precedente, questa tela mostra Cristo che
restituisce la vista ai ciechi. Anche qui si riscontra un forte realismo nel modo in cui
il giovane afferra saldamente il suo bastone, il violino ciondolante al suo fianco, mentre
riceve la vista dalla mano di Cristo. Dietro di lui, un giovane manifesta agitazione e
sorpresa e, come tale, fa da pendant al ragazzo con il cappello rosso posto dietro al
letto del figlio della vedova di Naim nell'altro dipinto. Le figure possenti, simili nelle
proporzioni al personaggio ricurvo del dipinto precedente, riempiono tutta la tela. L'atto
di guarire un mendicante è reso ancor più monumentale dal fatto che le figure sono
disposte su uno sfondo di architetture classiche. Tomory ha suggerito che i due dipinti,
rappresentanti due scene di guarigione, potrebbero essere stati commissionati
originariamente per la cappella dell'ospedale adiacente a S. Giovanni Battista dei
Genovesi a Roma (TOMORY [1974], p. 53). Tuttavia, essi sono stati collegati da Fanti (in
NEGRO-PIRONDINI [1994], p. 84) ad altre quattro opere aventi per soggetto episodi della
vita di Cristo, tutte menzionate nell'inventario Giustiniani del 1638: un dipinto
attribuito nel 1638 a Tommaso Campana, ma ora assegnato a Giuseppe Vermiglio (La
moltiplicazione dei pani e dei pesci, già Berlino, Kaiser Friedrich Museum, perduto), due
attribuiti ad Albani (fig. 1, Cristo e la Samaritana, Vienna, Kunsthistorisches Museum,
dal 1816; Cristo e la Cananea, Vienna, Salesianerinnerkloster Mariae Heimsuchung) ed un
dipinto di un "pittor lombardo" (Ingresso di Cristo a Gerusalemme, collocazione
sconosciuta). L'ipotesi è stata ripresa da Catherine Puglisi (PUGLISI [1999], pp.
130-131, n. 40), che nel catalogo dell'artista ha accolto il Cristo e la Samaritana come
opera autografa del 1615 circa. Allo stesso tempo, la studiosa nota che il dipinto
rappresentante Cristo e la Cananea, attribuito ad Albani nell'inventario Giustiniani del
1638, è di fatto una copia tratta dalla interpretazione del soggetto realizzata da
Annibale Carracci, già in collezione Farnese ed ora a Parma, Palazzo Comunale (in
prestito dal Museo di Capodimonte). La possibilità che i due dipinti di Fiasella
facessero parte di una serie di opere di soggetto cristologico è stata avanzata anche da
Anna Bava (Bava in ROMANO [1999], p. 204). Il raggruppamento proposto dalla studiosa
appare più logico, giacché comprende dipinti della stessa dimensione (palmi 11 ¥ 8),
che erano elencati con le opere di Fiasella nella sala adiacente alla galleria, all'epoca
in cui la collezione fu inventariata nel 1638 (SALERNO [1960], p. 102, nn. 159-164): due
dipinti attribuiti ad Albani (citati sopra) e due opere di Casale/Musso (Salita al
Calvario, Torino, Galleria Sabauda, cfr. scheda n. ###; Natività, forse quella oggi
conservata presso la Banca di Roma). È possibile che a queste sei opere si siano aggiunti
successivamente il dipinto del pittore lombardo ignoto e la tela di Vermiglio menzionati
nel 1638 "nella 1 stanza all'entrare della sala a man dritta, dell'appartamento dove
habitava la bo.mem.a del S.R. Gioseppe" (SALERNO [1960], p. 95, nn. 12, 13) e che,
poiché presentano dimensioni molto simili (palmi 12 ¥ 7), esse siano state commissionate
contemporaneamente da Vincenzo Giustiniani. All'epoca in cui si trovava nella collezione
di Lucien Bonaparte questa tela fu tradotta a stampa da Tommaso Piroli (1812), da Pietro
Fontana (1822) e da un ignoto incisore (come n. 210), cfr. EDELEIN BADIE [1997], p. 187.
Infine, il dipinto, al pari del suo pendant, risente sensibilmente dell'influenza delle
correnti artistiche romane degli anni 1607-1615 circa: i soggetti rappresentati sono molto
rari nella pittura genovese, e opere di tale iconografia (si considerino i casi di
Gioacchino Assereto, in un dipinto al Carnegie Institute, ex collezione Mowinckel, e di
Orazio de Ferrari in un dipinto conservato presso Palazzo Rosso a Genova) presentano uno
stile ed una composizione del tutto differenti. (Mary Newcome Schleier)
Sacra famiglia con S. Giovannino- Jean de Boulogne
L'opera proviene dalla collezione del marchese Vincenzo Giustiniani (IVANOFF [1966], pp.
3-4) e va identificata con quella elencata al n. 55 dell'inventario dei suoi beni
ereditari del 1638, pubblicato da Luigi Salerno (SALERNO [1960], p. 96), così descritta:
"Un quadro sopraporto con la Madonna, e Cristo bambino, e S. Giovannino, che tiene
una canestra di frutti, e S. Giuseppe, dipinto in tela, alta 6 e larg. 8 in circa di mano
di Monsù Valentino francese con cornice". Nel 1725 il Pinaroli (PINAROLI [1725], p.
274) la indica ancora tra le opere di palazzo Giustiniani, sebbene la registri
semplicemente come "Sacra Famiglia", omettendo la figura di S. Giovannino. Alla
famiglia Spada è quindi passata successivamente a tale data, probabilmente in epoca
ottocentesca, se tra gli inventari del Fondo Spada Veralli viene menzionata per la prima
volta nell'appendice al fidecommesso del 1862, dove è riportata col diverso titolo di
"Adorazione del Bambino", ma riferita correttamente al Valentin (CANNATÀ-VICINI
[1992], p. 190, n. 93). È inoltre presentata nella "Terza camera", ossia
nell'attuale terza sala del museo, diversamente da oggi, visibile nella quarta sala,
insieme ad altre opere di matrice caravaggesca della collezione Spada che Federico Zeri
riunì nel 1951 durante la fase di riassetto della galleria per la sua riapertura
ufficiale al pubblico. Nella stessa sala, detta proprio dei "Caravaggeschi", è
presente un altro dipinto del Valentin raffigurante Salomè con la testa del Battista
(fig. 1) appartenuto forse al cardinale Bernardino Spada (1594-1661) (CANNATÀ [1995], p.
126). La Sacra famiglia con S. Giovannino non fu tuttavia l'unica opera dell'eredità
Giustiniani che giunse a palazzo Spada. Essa venne accompagnata contemporaneamente da un
altro dipinto, pure di grandi dimensioni, del pittore Angelo Caroselli (1585-1652) (GIFFI
[1986], pp. 2 e 30, n. 46, fig. 67) (CANNATÀ-VICINI [1992], p. 54, nota 73; p. 190, n.
159) raffigurante il biblico soggetto del Figliol prodigo, ora esposto nel piano nobile
dell'edificio (SALERNO [1988], p. 682). Sempre con il riferimento al Valentin e come
"Adorazione del bambino" è ricordata nella ricognizione inventariale del 1925
effettuata dall'avvocato Pietro Poncini, amministratore degli Spada, e nella coeva stima
di Hermanin che la valuta L. 15.000 (CANNATÀ-VICINI [1992], pp. 193 e 198).
L'attribuzione al pittore da parte di Barbier de Montault (BARBIER DE MONTAULT [1870])
resta di seguito invariata (DUSSIEUX [1876]; VOSS [1924a]; HERMANIN [1925]; PORCELLA
[1931]; LAVAGNINO [1933]). Anche Zeri (ZERI [1954], pp. 142-143), riconosce nell'opera la
mano del Valentin e ne riscontra strette affinità sia con il nucleo dei dipinti del Museo
del Louvre che con il Martirio dei SS. Processo e Martiniano della Pinacoteca Vaticana.
Propone una datazione verso il 1630, corrispondente alla fase matura dell'artista, quando
persistevano gli influssi di Simon Vouet che ravvisa soprattutto nella figura della
Vergine. Secondo Marina Mojana (MOJANA [1989], p. 136), la data di esecuzione del dipinto
oscilla tra il 1626 e il 1629 ed è prossima per motivi stilistici e di resa pittorica a
quella del S. Girolamo e del S. Giovanni Battista della chiesa di S. Maria in Via di
Camerino e contemporanea all'Erminia tra i pastori dell'Alte Pinakothek di Monaco,
caratterizzata dalla stessa animazione dei personaggi, legati tra loro da una comunione di
gesti e sguardi. Nato in Francia, a Coulomniers en Brie, il 3 gennaio del 1591, Le
Valentin - detto de Boulogne per una supposta origine italiana (IVANOFF [1966], p. 1), o
più probabilmente in riferimento alla cittadina Boulogne-sur-Mer, in Piccardia, come è
più propensa a credere la critica moderna (MOJANA [1989], p. 3) - si stabilì
giovanissimo a Roma nel quartiere di S. Maria del Popolo dove strinse immediatamente
contatti con la schiera di artisti nordici, lì residenti, attenti alla rivoluzione
caravaggesca che ferveva nell'ambiente romano e di cui il lombardo Bartolomeo Manfredi
(1582-1622) era considerato il massimo rappresentante. L'adesione agli ideali
caravaggeschi, suscitata da tali frequentazioni e senz'altro maturata e approfondita dallo
studio diretto delle opere del Merisi che egli poté osservare in S. Maria del Popolo e in
S. Luigi dei Francesi, apparve un percorso inevitabile per il giovane francese esordiente
e di talento, ma privo di un proprio linguaggio artistico, con il solo bagaglio di
esperienze acquisite nella bottega del padre, un artigiano pittore di vetri. Agli anni
1615-1618 risalgono i suoi primi capolavori con temi cari agli artisti fiamminghi e
olandesi e fortemente legati alla lezione caravaggesca, quali ad esempio Cristo deriso e
incoronato di spine, di collezione privata, Inghilterra; il Concerto a tre personaggi
della collezione Devonshire, di Chatsworth; il Baro, della Gemäldegalerie Alte Meister di
Dresda; Cristo caccia i mercanti dal Tempio, della Galleria Nazionale d'Arte Antica di
palazzo Barberini. Opere attribuite talvolta allo stesso Caravaggio, contrassegnate dalla
resa drammatica delle scene e della luce cruda che colpisce i protagonisti rivelandone le
caratteristiche volumetriche e psicologiche, e che risentono in particolare degli influssi
del Manfredi nella materia compatta e nella tipologia dei volti; del Saraceni, che il
Valentin ebbe modo di conoscere, nella resa coloristica; e, nel modellato ben definito
delle figure, del belga Gérard Douffet, attivo a Roma tra il 1614 e il 1622, con cui il
Valentin divise l'abitazione in via Margutta tra il 1614 e il 1622 (MOJANA [1989], p. 21).
Negli anni che seguono, fino alla morte avvenuta nel 1632, il caravaggismo di fondo della
prima attività si evolve man mano in una visione più personale e meno drammatica, con
toni dolci e malinconici, sensibilità raggiunte a contatto con le colte personalità
degli ambienti del marchese Giustiniani e di Cassiano dal Pozzo, nei quali fu introdotto
dal cardinale Francesco Barberini, suo protettore. I suoi interessi si spostano pertanto
verso il Guercino, il Reni, l'ambiente napoletano del Ribera e soprattutto verso i
connazionali francesi, specie il Vouet, la cui arte si pone alla base delle due opere
Spada. Nella Sacra Famiglia con S. Giovannino il fascio di luce caravaggesca che muove
dalla figura di S. Giuseppe e si irradia sempre più culminando sull'immagine di Maria,
suggerisce anche un ideale percorso di lettura della scena. S. Giuseppe, dallo sguardo
preoccupato, spinge Giovanni Battista ad offrire al Cristo Bambino la cesta colma di pomi,
elementi che prefigurano la sua morte in allusione ai pomi del peccato originale da lui
redento, e di uve, simbolo del vino eucaristico e riferimento al sacrificio di Cristo. Ma
il Bambino, timoroso e perplesso, implora conforto alla madre che con dolce fermezza lo
aiuta a tendere il braccio verso la croce stessa e i frutti. Il Battista fu il precursore
di Cristo, o nunzio del Cristo, colui che sulle rive del fiume Giordano preparò la sua
venuta e profetizzò la sua passione andando egli stesso incontro al martirio. Proprio
nell'altro citato dipinto del Valentin presente in sala si assiste alla sua fine: Salomè,
figlia di Erodiade, esibisce sul piatto d'argento la sua testa, dopo averne chiesto la
decapitazione ad Erode (fig.1). Egli è qui raffigurato fanciullo, con il suo attributo
della croce per preparare lo stesso Cristo, ancora bambino, alla sua futura missione di
redenzione umana. La Madonna, che assiste il figlio incoraggiandolo a prendere i simboli
che alludono al suo doloroso destino, rimanda ai significati di mediatrice nel disegno di
salvezza dell'uomo e di madre della chiesa. Il pittore si era già espresso con il tema
della prefigurazione della passione e morte di Cristo nella giovanile opera raffigurante
la Sacra Famiglia con Angeli (Madrid, Banco Exterior de España) dove è Maria che nella
sua funzione di mediatrice di salvezza solleva dalle mani dell'angelo il vassoio di uve,
mentre Giuseppe invita Gesù ad osservare la scena. A differenza della tela di Madrid, il
dipinto Spada si caratterizza per la carica espressiva dei personaggi e per l'intenso
colorismo, reso dalle pennellate fluide ed estese con toni lillà ed arancio. Soluzioni
artistiche della fase matura del pittore che fanno dell'opera un eccellente esempio di
interpretazione del caravaggismo a Roma in cui si avvertono gli influssi del Vouet
nell'eleganza formale e descrittiva, con attenzione verso i modi di Poussin, Guercino e
Guido Reni. (Maria Lucrezia Vicini)
Cristo appare alla Madre per annunciarle la morte - Bartolomeo
Manfredi
Il dipinto è citato nell’inventario del 1638 della collezione Giustiniani al n. I,
135: "Un quadro di Christo, che apparisce alla Madonna, dopo la Resurrettione dipinto
in tela, alta palmi 12 lar. 8 in circa senza cornice di mano di Bartolomeo Manfredi"
(SALERNO [1960], p. 101). La descrizione corrisponde esattamente al quadro e non dà luogo
a dubbi sull’identificazione compiuta dal Salerno (SALERNO [1974], p. 616). È degno
di nota anche il rilievo che il dipinto era senza cornice. L’opera sicura ha
avvalorato la ricostruzione della personalità di Bartolomeo Manfredi proposta dal Longhi
(LONGHI [1943], p. 49) sulla base dei dipinti degli Uffizi, in antico riferiti al
Caravaggio, ma corrispondenti ai temi per i quali il Manfredi era diventato famoso. Le
misure fanno ritenere che il dipinto fosse di destinazione chiesastica (lo conferma la
prospettiva per una visione dal basso, MERLO [1987], p. 84) e ciò potrebbe porsi in
relazione con l’affermazione del Mancini che, al tempo in cui scriveva, il Manfredi
"comincia a far dell’opere publiche" (MANCINI [1617-1621, ed. 1956-1957],
vol. I, p. 251). La circostanza che il Cristo appare alla Madre fosse senza cornice fa
pensare a due possibilità: che il dipinto fosse stato rifiutato dai committenti e
ritirato di conseguenza dal Giustiniani, oppure che fosse rimasto nello studio del pittore
alla sua morte e parimenti ritirato dal collezionista. Per la seconda ipotesi propende il
Merlo (MERLO [1987], p. 84), che ritiene il dipinto non completato in alcune parti. Il
raro tema rientra nei soggetti post mortem trattati dal Caravaggio e anche il concetto è
intimamente caravaggesco nella essenzialità del rapporto tra le due figure e nella
intensità degli "affetti" che ne consegue. Il Manfredi ha scelto
l’incontro post mortem con la Madre, vestita da vedova, che i Vangeli apocrifi
riferiscono avvenuto dopo la resurrezione per annunciarle la morte imminente. Il Cristo
glorioso, come di norma, si presenta ancora con le ferite al costato e alle mani. Nel
piede del Cristo si nota un pentimento e la sua sproporzione indica un’esecuzione
senza disegno che segue da vicino il metodo caravaggesco, come si rileva anche nelle mani
della Madonna. Uno specifico omaggio al Caravaggio si nota nello scorcio della mano del
Cristo protesa verso il riguardante che si rifà al celebre pensiero rappresentato
nell’apostolo a destra dell’Emmaus di Londra. La tipologia della Madonna vista
nell’atto di girarsi ha attinenza con il viso della donna al centro della Riunione di
bevitori di Los Angeles ed è un ricordo di Pero che allatta Cimone nelle Sette opere di
misericordia del Pio Monte di Napoli, ciò che attesta la conoscenza delle opere
napoletane del Merisi da parte del Manfredi.(Mina Gregori)
Amore vincitore - Caravaggio
Il fanciullo dà corpo al passo virgiliano "Amor vincit omnia et nos cedamus
amoris" (Egloghe X, 69), questa è l'interpretazione più famosa del celebre,
indiscusso dipinto, data da FRIEDLÄNDER [1955], pp. 91-94, 182-183, e in seguito sempre
accolta e riproposta. In effetti l'accostamento è tutt'altro che arbitrario; non è stato
finora segnalato come Vincenzo Giustiniani, che si ritiene abbia ampiamente influenzato il
Merisi, dia prova di cultura latina attraverso l'inventario della biblioteca (DANESI
SQUARZINA [2001]) e in molti passi dei suoi scritti, fra l'altro citando proprio il poeta
mantovano: "…come disse Virgilio: Aere ciere viros Martemque accendere
cantu" (Eneide, VI, 165; Discorso sopra la musica, GIUSTINIANI [s.d., ed. 1981], p.
30), una cultura, quella del committente, cui Caravaggio rende un implicito omaggio. In
ottimo stato di conservazione, esso costituisce oggi il punto focale di una sala della
Gemäldegalerie di Berlino dedicata al Seicento italiano; sette palmi per cinque
d'altezza, ossia formato di "tela d'imperatore", collocato in posizione
privilegiata, "nella stanza grande de quadri antichi", è descritto
nell'inventario del 1638, redatto alla morte del marchese Vincenzo Giustiniani, con parole
che, più di ogni altra definizione, ce ne rendono la ricezione a quel tempo: "Un
amore ridente, in atto di dispregiar il mondo" (SALERNO [1960], p. 135). Solitamente
viene accostato al S. Matteo con l'angelo, la pala che Caravaggio eseguì per l'altare
della cappella Contarelli in S. Luigi dei Francesi, e che, rifiutata, fu acquistata da
Vincenzo Giustiniani, opera purtroppo perduta nell'incendio del Flakturm di
Friedrichshain, Berlino, da collocare nell'ambito del primo impegno di Caravaggio come
pittore di storia (SPEZZAFERRO [1980]). Su base stilistica anche l'Amore viene datato al
1602; il termine ante quem è costituito dagli interrogatori seguiti alla querela per dei
versi diffamatori intentata contro il Merisi, Orazio Gentileschi, Onorio Longhi e Filippo
Trisegno da Giovanni Baglione (BERTOLOTTI [1881], vol. II, pp. 51-64; VOSS [1922], pp. 60
e ss.; VOSS [1923], pp. 95 e ss.); il 14 settembre 1603 Orazio Gentileschi dichiara che
Baglione aveva eseguito un "Amor devino […] a concorrenza di un Amor terreno de
Michelangelo da Caravaggio". Questo accenno al Baglione apre una complessa serie di
relazioni con i due dipinti del medesimo, qui esposti in mostra, vedi le relative schede,
infra; in sostanza Baglione, che all'inizio del Seicento si rivolge a una pittura che
discende dall'odiato rivale Caravaggio, avrebbe offerto un dipinto al cardinale Benedetto,
che "se bene dicto quadro non piacque quanto quello de Michelangelo, lo premiò con
una collana". Il dipinto offerto era l'Amore divino in prima versione (tela di
Berlino) tutto rivestito di corazza metallica, e in seconda versione (tela di palazzo
Barberini) rifatto con maggiori concessioni alla critica rivoltagli da Gentileschi (vedi
sempre atti del processo), che Amor divino avrebbe dovuto "esser nudo e putto",
frase rivelatrice di come si dovesse all'epoca raffigurare tale soggetto. Il ritrovamento
degli inventari del cardinale (DANESI SQUARZINA [1997], pp. 783-784) ha dato conferma al
testo degli interrogatori; i due Amori divini di Baglione erano di Benedetto Giustiniani e
già nell'inventario del 1621 risultano appesi nella galleria. Nel restauro del 1979 è
stata rinvenuta, sul quadro di Baglione, Amor sacro e amor profano, palazzo Barberini, la
firma e la data 1602, che ben si attaglia a quanto ci dicono i documenti; anche per questo
l'Amore vincitore di Caravaggio non può essere posteriore al 1602. C'è poi una
testimonianza del Baglione medesimo (BAGLIONE [1642], p. 138), per cui Caravaggio avrebbe
dipinto per il cardinal Del Monte un Amore divino che sottomette amor profano, opera
sconosciuta, secondo MARINI ([1974], p. 397) ricostruibile attraverso una copia in
collezione privata. La deposizione di Gentileschi dice inoltre: "Caravaggio ha
mandato a casa mia per una veste da cappuccino che gliela prestai e un par d'ale";
nel paio d'ali prestate è stato intravisto il modello "al naturale" delle
grandi ali brune dell'Amore vincitore; il processo costò a Caravaggio, preso in piazza
Navona, una breve prigionia a Tor di Nona; il 25 settembre 1603 il governatore di Roma, su
intercessione dell'ambasciatore di Francia, rilasciò l'artista (BERTOLOTTI [1881], vol.
II, p. 64; SAMEK LUDOVICI [1956], p. 159). Secondo Sandrart la liberazione avvenne per
merito di questo dipinto. Gli atti del processo ci restituiscono peraltro una fondamentale
dichiarazione di poetica del Merisi: "depinger bene e imitar bene le cose
naturali". Un limite ante 1603 è offerto inoltre da un madrigale (MURTOLA [1603, ed.
1604], pp. 468-470; CINOTTI [1971], p. 164, f. 110a, b) del Murtola; il poeta genovese,
segretario del duca Carlo Emanuele di Savoia e grande nemico del Marino, si indirizza al
pittore e parla di Amore "che ha seco gli strali, amorosi e mortali". Marzio
Milesi gli dedica versi in latino, inseriti nell'epitaffio per la morte di Caravaggio
(CINOTTI [1971], p. 162, f. 93) ispirati al tema virgiliano di Amore che vince ogni cosa,
"De Michaele Angelo da Caravaggio, qui Amorem omnia subigentem pinxit". Il
distico non è datato, sappiamo però che Milesi era in contatto non solo con Caravaggio,
ma già nei primissimi anni del Seicento anche con i Giustiniani, poiché ci è pervenuta
la sua trascrizione di una iscrizione latina, a margine di un bassorilievo raffigurante
una bottega di macellaio, "in vinea iustinianea" conservato allora nella villa
al Muro Torto, di proprietà di Benedetto Giustiniani (DANESI SQUARZINA [1998c], pp. 275,
290). Per una discussione della cronologia degli eventi vedi BISSEL [1974], la cui
proposta di retrodatare il dipinto non ha trovato accoglimento; è indubbio che il luogo
del confronto fra Baglione, Gentileschi e indirettamente Caravaggio, fu la mostra che si
teneva annualmente nel cortile di S. Giovanni Decollato (e non S. Giovanni dei Fiorentini,
come dichiara erroneamente Gentileschi e come ritiene MARTINELLI [1959], p. 85) ossia, in
questo caso, il 29 agosto 1602, altro concreto termine ante quem. Vediamo dispiegati a
terra, come dice l'inventario, "diversi stromenti, Corone, Scettri, et armature"
che simboleggiano sia i piaceri terreni che Amore dispregia e signoreggia, sia i vasti
interessi culturali di Vincenzo Giustiniani, a cui si riferirebbe la lettera V, sullo
spartito che giace visibile sul pavimento (TRINCHIERI CAMIZ- ZIINO [1983]); Enggass vede
evocate da Caravaggio le "virtù di un vero nobile" (AMAYDEN [1640 circa, ed.
1914], pp. 455 e ss.) espresse negli scritti multidisciplinari di Vincenzo Giustiniani, e
"omnia vincit amor" si traduce in "omnia vincit Vincentius"; il forte
divario cronologico non consente di tracciare meccanici rapporti di causa/effetto,
tuttavia è innegabile che gli interessi del committente si riflettano nel dipinto come in
uno specchio; al momento dell'esecuzione del quadro Vincenzo si avvicinava ai quarant'anni
e aveva compiuto solo in minima parte le opere per le quali è poi ricordato, né aveva
ancora steso i suoi scritti sull'arte, tutti databili dopo la morte di Caravaggio (la
presenza di squadra e compasso va vista in senso lato e non riferita a costruzioni non
ancora intraprese). I vari "Discorsi" sopra la pittura, la scultura, la musica,
l'architettura, la caccia, il far viaggi, di cui manca una cronologia documentata, sono
tuttavia databili attraverso allusioni a eventi storici inseriti al loro interno (DANESI
SQUARZINA [1998a], nn. 111-112) e comunque tutti successivi di oltre un decennio al
dipinto; si avverte semmai che esso esprime dei contenuti già oggetto di dotte e
piacevoli conversazioni, ad esempio l'uso di suonare il liuto, soppiantato dalla tiorba
"per schivare la gran difficoltà, che ricerca il saper sonar bene di Liuto"
(GIUSTINIANI [s.d., ed. 1981], p. 34); si può addirittura sostenere che la tela dia una
forma anticipatrice alla teoria che poi Vincenzo metterà sulla carta, circa il rapporto
fra maniera e naturale; anche quanto Vincenzo scriverà sull'importanza di Michelangelo
(GIUSTINIANI [s.d., ed. 1981], pp. 69-70) sembra qui precorso nel putto a gambe larghe,
come gli Ignudi della Cappella Sistina, in particolare quello sopra la Sibilla Persica.
Certamente Caravaggio conosceva gli affreschi del Buonarroti e lo dimostra nel S. Giovanni
Battista (Musei Capitolini), mentre è più difficile sostenere che avesse visto la statua
della Vittoria oggi a Firenze, Palazzo Vecchio, secondo FRIEDLÄNDER [1955] modello per la
posa trionfante, a gambe divaricate dell'Amore. Il dialogo fra l'artista e il suo maggiore
committente sembra rimbalzare attraverso il tempo: l'Amore vincitore non è un quadro di
genere; anche se in primo piano ci mostra un dispiegamento di oggetti emulo di questa
specialità, esso ne costituisce il superamento verso un enigmatico livello simbolico.
Sarà proprio Vincenzo nel suo Discorso sopra la pittura (GIUSTINIANI [s.d., ed. 1981], p.
42) a riferire la frase di Caravaggio: "Tanta manifattura gli era a fare un quadro
buono di fiori, come di figure", esplicita, lapidaria negazione degli steccati fra i
"generi" in pittura. Amore simboleggia le cose del mondo, anche le più nobili,
nulla di ciò che è ai suoi piedi è deteriore, egli le domina, le possiede, poiché Amor
vincit omnia, facendoci cogliere, senza adulazione e anzi con l'insuperabile ambiguità
dell'arte, la cosidetta "sprezzatura", termine ricorrente negli scritti del
tempo che ben si addice al marchese-mercante a cui Ameyden ([1640 circa, ed. 1914], p.
455) attribuisce "tutte le virtù di un vero nobile" e del quale fonti
contemporanee sottolineano l'amabilità e il tratto cortese. C'è un particolare modo di
porsi del gentiluomo che accompagna le sue sortite nel mondo dell'arte; i suoi scritti non
vogliono essere mai una iniziativa autonoma, Vincenzo mette mano alla penna perché
sollecitato, e spinto a dare una risposta alle insistenze cortesi dell'amico Ameyden; il
topos della lettera di replica che si apre con una formula "mi sovvenne di scriverle
in risposta alla richiesta" (GIUSTINIANI [s.d., ed. 1981], p. 17) ricorre, iterato
più volte, all'inizio di ogni capitolo. Anche l'immenso lavoro dei due volumi della
Galleria Giustiniana, spazio mentale prima che fisico, a cui il marchese dedicò gli
ultimi dieci anni della sua vita, reca in calce una tabella che suona ugualmente
dichiarazione di attitudine schiva, restìa all'esibizione di sé e delle proprie
competenze e inclinazioni artistiche: "…quanto si è operato per dar
soddisfattione a molti che ne hanno fatta lunga istanza". Il distacco era solo
esteriore, Vincenzo era proteso a dar corso alle proprie doti naturali. Egli trasmetteva
la sua personalità sia in modo indiretto, guidando gli artisti di genio (Caravaggio,
Poussin) e indirizzando i più giovani e devoti, sia in modo diretto, manifestando talenti
di architetto e ideatore di giardini - la villa e il giardino al Laterano, il palazzo e il
giardino di Bassano Romano, la chiesa di S. Vincenzo Martire nello stesso ameno territorio
-, una attività intensa e multiforme cui egli stesso fa cenno più volte (GIUSTINIANI
[s.d., ed. 1981], pp. 51-62). Una collezione tutta di quadri a tema sacro sembra estranea
al provocante tema laico dell'amore "terreno". Ma non possiamo non sottoporre a
revisione e dubbio il ricorrere di questo aggettivo nelle numerose fonti, nessuna
autorizzata dall'autore; Tiziano ci insegna che amor sacro è nudo, ed è attraverso i
modelli cinquecenteschi, precontroriforma, che il Merisi filtra la sua ripresa del vero;
con le sue ali brune, che Sandrart definisce d'aquila, il putto è destinato a volare
alto, e ad abbracciare con lo sguardo l'orbe stellato su cui siede con noncuranza. Un
amore generante e totalizzante, che ha sulla sfondo la "natura naturante o
naturata" (GIUSTINIANI [s.d., ed.1981], p. 27) e "armonie terrene",
espressione di quell'empatia o "simpatia naturale" di cui parla il marchese
(GIUSTINIANI [s.d., ed.1981], p. 75), discussa in CROPPER-DEMPSEY [1996], p. 100 e passim,
nutrita di letture platoniche ("e se Platone avesse formato così bene le sue
immaginate idee, non resterebbe ora così ripreso e schernito; sebbene all'incontro si
può scusare che non avendo il lume della Fede, andava a tentoni investigando le cagioni
delle cose" (GIUSTINIANI [s.d., ed. 1981], p. 60) e forse di contatti con Federico
Cesi attraverso Cassiano dal Pozzo, dato che si legge in Vincenzo l'espressione
"filosofia naturale" (GIUSTINIANI [s.d., ed.1981], p. 104) proposta in un
complesso contesto (BALDRIGA [1998-1999]) dal fondatore dell'Accademia dei Lincei. Un
dipinto in cui la calcolata disparità fra la quotidianità naturalistica del modello e la
portata universale del contenuto stride e urta l'osservatore nello stesso momento in cui
lo conquista. Il dibattito sul significato reale del fanciullo che sottomette i simboli
dell'erudizione, delle scienze, della musica, del potere (mancano solo la pittura e la
scultura) ha avuto tappe e accostamenti; per i Trionfi di Petrarca vedi FROMMEL [1971a],
p. 48; il dubbio più rilevante riguarda la sua natura terrena ovvero divina (vedi a
questo proposito CALVESI [1966], p. 302, nota 1; [1971], p. 108); Calvesi ([1990], p. 241)
segnala come possibile modello gli affreschi di Polidoro da Caravaggio nella cappella di
Fra' Mariano a S. Silvestro al Quirinale in Roma e precisamente una figurazione del
basamento con il motivo di erote e anterote; e indica come ricca fonte iconografica una
incisione di Agostino Carracci su disegno di Antonio Campi raffigurante l'Allegoria di
Cremona (CALVESI [1990], p. 240, fig. 124). Vedi inoltre PRAZ [1977], p. 81, che introduce
un paragone con l'angelo sorridente che rivolge la sua freccia verso la S. Teresa del
Bernini. Il neoplatonismo, il cui revival inizia già nel sec. XV, sottolinea come
nell'amore vi siano due componenti, due forze compresenti, una positiva e una negativa, a
volte raffigurate in due cavalli, uno bianco, a destra, uno nero, a sinistra; la
simbologia di una corda "recta" dei sentimenti e una sinistra, da non
assecondare, pare allusa dai due strumenti musicali che appaiono nel dipinto di Caravaggio
(fra cui il violino che, come notato da DISERTORI [1954], pp. 28-29 e FRIEDLÄNDER [1955],
p. 92, era stato da poco inventato a Cremona) muniti di corde solo sulla metà destra. Le
frecce di Amore, una segnata di rosso e l'altra di nero (FRIEDLÄNDER [1955]), possono
alludere alle due polarità possibili. Si segnala che l'Amore dormiente dell'Antella,
Firenze, palazzo Pitti, Galleria Palatina, interpretabile come sonno dei sensi, ha in mano
una sola freccia striata di rosso. Oltre alla evocazione del Ganimede di Michelangelo per
Tommaso de' Cavalieri (CLARK [1966], p. 17 e ss.) - peraltro, in collezione era presente
un Ratto di Ganimede derivato dalla incisione di Beatrizet a sua volta tratta dal disegno
di Michelangelo, vedi scheda ###) - è stata sottolineata la nudità impudente (RÖTTGEN
[1974], p. 197) e tentata una ipotetica chiave di omosessualità (FROMMEL [1971a], pp. 49
e ss.; POSNER [1971b], p. 314), o di sublimazione di essa (FREEDBERG [1983], p. 59), tema
di cui peraltro non si coglie alcuna eco nelle fonti fondamentali che descrivono il
fanciullo come un Cupido (BAGLIONE [1642], p. 137; BELLORI [1672], p. 207; SCANNELLI
[1657]; p. 199; SILOS [1673], n. CXLIV); Sandrart (SANDRART [1675, ed. 1925], pp. 276 e
ss.), che fu in rapporto con Vincenzo Giustiniani dal 1629 al 1635, racconta che se
l'Amore vittorioso veniva tenuto coperto da una tendina verde scuro era per non eclissare
le altre rarità, e solo dopo aver esaminato gli altri dipinti vicino ai quali era appeso,
il visitatore era ammesso a vedere la tela scoperta. Però negli inventari Giustiniani, in
cui sovente sono menzionate "bandinelle di ormesino", nulla è detto per questo
dipinto. Wagner (WAGNER [1958], p. 81) e Gregori (GREGORI [1972], p. 38) hanno
sottolineato uno stretto rapporto degli strumenti musicali e altri oggetti ai piedi
dell'Amore con la natura morta che giace ai piedi della S. Cecilia di Raffaello, all'epoca
nella sua cappella in S. Giovanni in Monte a Bologna; a questa importante notazione va
aggiunto che a Roma, in S. Luigi dei Francesi, cappella Polet è conservata una copia
appunto della S. Cecilia eseguita da Guido Reni, una grande tela (cm 220 ¥ 126) che
Pepper (PEPPER [1969], pp. 353-355, n. 23) data al primissimo soggiorno a Roma del
bolognese, iniziato nel 1601. In conclusione il dipinto fa da punto di passaggio fra le
opere di tema, per lo meno in apparenza, laico-edonistico, e quelle di manifesto impegno
religioso; benché la controversia fra una interpretazione terrena o divina dell'Amore
vincitore sia destinata a restare irrisolta, si coglie nei valori coloristici e formali il
repentino maturare dell'artista verso un'aderenza al vero senza compiacimenti, senza
timore di urtare la sensibilità dello spettatore e una tesa padronanza dell'anatomia dei
modelli antichi, che le collezioni romane e la cultura dei suoi protettori gli offrivano.
Una testimonianza del grandissimo valore attribuito al dipinto durante il Seicento è
contenuta nel diario di viaggio di Richard Symonds che soggiornò in Italia dal 1649 al
1651 (BEAL [1984]; WIEMERS [1986]). Inoltre, sulla base della descrizione offerta da
Symonds, Papi (PAPI [1996]) ha proposto di riconoscere nel giovinetto raffigurato il
pittore Francesco Buoneri, meglio noto come Cecco del Caravaggio. Nel 1984 è stato
eseguito un restauro (Gerhard Pieh) sotto la supervisione di Erich Schleier, il quale mi
riferisce che il dipinto non presentava lacune ed era in buone condizioni; veniva però
rilevato uno stato di sofferenza delle parti chiare, ossia il corpo del fanciullo; lì il
colore si presentava molto asciutto, secco, magro, ma non abraso. La pulitura ha messo in
evidenza la stesura del colore tipica di Caravaggio, con sapienti riprese a pennello dei
punti di incontro fra campi chiari e zone scure, per meglio sottolineare i contorni. Per
le incisioni rilevabili sulle ali, sul liuto e sul violino, vedi l'ottima scheda di Mina
Gregori in NEW YORK-NAPOLI [1985], pp. 277-281, n. 79; un pentimento percepibile sul
fianco sinistro del fanciullo come una striscia più chiara del fondo (SCHLEIER [1978], p.
91) dalle radiografie, eseguite nel 1984, appare essere una estensione del banco, coperto
a destra da un lenzuolo, su cui egli si appoggia, eliminato a causa dell'inserimento del
globo stellato. La penna era in origine a sinistra e qualche modifica è stata apportata
al panneggio. Si rileva l'uso dell'oro in foglia per le stelle e per la corona. Nella
ristretta scelta di dipinti appartenenti alla sua collezione, che Vincenzo Giustiniani
volle inserire nel secondo volume della Galleria Giustiniana (s.d., 1637 circa), manca
l'Amore vincitore e manca parimenti qualsiasi altra opera a tema sacro di Caravaggio,
facente parte della raccolta; in ciò si può forse cogliere una radicale evoluzione del
gusto del committente, ovvero semplicemente un progetto incompiuto di terzo volume con
maggiore corredo di immagini. (Silvia Danesi Squarzina)
Suonatore di liuto - Caravaggio
Il dipinto era collocato nella "Stanza grande dei quadri antichi",
insieme ad altre dodici tele di Caravaggio. Il soggetto rappresentato, un giovane che
canta un madrigale d'amore accompagnandosi con il liuto, lascia intendere che l'opera fu
eseguita espressamente per il marchese Vincenzo Giustiniani, grande appassionato e
conoscitore di musica. Come noto, infatti, Vincenzo scrisse un Discorso sopra la Musica
(1628 circa) nel quale egli, pur dichiarandosi un dilettante, rivela di essere ampiamente
informato sulle novità dell'epoca in tema di canto e di composizione. Non vi è dubbio,
pertanto, che il dipinto sia stato eseguito da Caravaggio seguendo le precise indicazioni
del marchese, tanto più che l'efebico musico sta suonando un pezzo del celebre
compositore fiammingo Jacob Arcadelt, le cui partiture Vincenzo aveva studiato da giovane
("Che nella mia fanciullezza mio padre b. m. mi mandò alla scola di musica, et
osservai ch'erano in uso le composizioni dell'Archadelt, di Orlando Lassus, dello Strigio,
Cipriano de Rores e di Filippo di Monte, stimate per le migliori di quei tempi, come in
effetto erano", GIUSTINIANI [s.d., ed. 1981], p. 20). Dobbiamo agli importanti studi
di Franca Trinchieri Camiz (TRINCHIERI CAMIZ-ZIINO [1983]; SLIM [1985], pp. 243-244)
l'identificazione dello spartito che il Suonatore tiene davanti a sé: si tratta del
madrigale d'amore intitolato "Voi sapete ch'io v'amo", pubblicato nelle numerose
edizioni del Primo libro di madrigali dell'Arcadelt. Nell'ambiente aristocratico romano di
fine Cinquecento e inizio Seicento, il far musica rientra nelle attività virtuose del
gentiluomo e, come lo stesso Giustiniani rivela nei suoi scritti, costituisce un piacevole
diletto da condividere con i propri pari: "…alcuna poca esperienza da me
acquistata mentre ho tenuto conversazione in casa senza l'esercizio del gioco, ma con
altre virtuose occupazioni, e particolarmente con questa della musica, esercitata senza
concorso di persone mercenarie, tra gentiluomini diversi, che se ne prendevano diletto e
gusto per inclinazione naturale" (GIUSTINIANI [s.d., ed. 1981], p. 18); e parlando
della propria casa, Vincenzo afferma che "tra gli altri esercizij onorati" vi
"era in uso la musica" (GIUSTINIANI [s.d., ed. 1981], p. 136). Tra i
frequentatori abituali di tali incontri armonici dovevano essere il cardinale Montalto,
che "sonava di Cimbalo egli per eccellenza, e cantava con maniera soave et
affettuosa" (GIUSTINIANI [s.d., ed. 1981], p. 24; CHATER [1987]), e Francesco Maria
del Monte. Con quest'ultimo, in particolare, il Giustiniani condivideva numerosi
interessi, che spaziavano dall'astrologia, all'esoterismo, all'attrazione per le terre
lontane (WAZBINSKY [1994]). Rispetto alla musica, inoltre, se Vincenzo si discosta da
coloro che tendono a riconoscervi l'ordine dell'armonia universale, non ne smentisce però
le proprietà curative e pseudo-magiche ("si può dir veramente, che ne gl'effetti
che procedono dalla musica, la natura vi abbia gran parte, accompagnata anche
dall'arteficio…" (GIUSTINIANI [s.d., ed. 1981], p. 31). Non vi è dubbio che su
tali questioni egli poté incontrare nel Del Monte, noto appassionato di alchimia, un
interlocutore informato. Tra gli oggetti personali del marchese figurano pochi strumenti
musicali, ovvero "Un Cimbalo lungo con la cassa di sopra abbrugiata in opra" ed
"Un'organo in forma di tavolino in opra" (inv. 1638), tuttavia la sua conoscenza
in materia doveva essere molto approfondita. Nei suoi scritti, il marchese descrive con
precisione le differenze tra uno strumento e l'altro, ed esalta specialmente la bellezza
del suono del liuto, che richiedendo una grande abilità all'esecutore è divenuto sempre
più raro: "Era anche per il passato molto in uso suonare di Liuto; ma questo
stromento resta quasi abbandonato affatto, dappoiché s'introdusse l'uso della Tiorba, la
quale essendo più atta al cantare anche mediocremente e con cattiva voce, è stata
accettata volentieri generalmente, per schivare la gran difficoltà, che ricerca il saper
sonar bene il Liuto" (GIUSTINIANI [s.d., ed. 1981], p. 18; su questo cfr. MARINI
[1989], p. 400). Non può sfuggire, inoltre, che l'esercizio armonico praticato da
Vincenzo si incontrasse perfettamente con la sua profonda conoscenza dell'antico. È egli
stesso, nel Discorso sopra la Musica, a ricordare Pitagora e Platone circa la capacità
della musica di suscitare le più diverse emozioni negli ascoltatori, dal sorriso, al
pianto, all'ira (del Timeo di Platone Vincenzo possedeva il commento di Paolo Beni).
Inoltre, Vincenzo conosceva di certo il De Musica di Plutarco, contenuto come noto nella
raccolta dei Moralia, menzionati nell'inventario della sua biblioteca. I miti
"musicali" antichi, come quelli di Orfeo e di Apollo erano, oltretutto, quanto
mai familiari al Giustiniani, che nel proprio palazzo poteva goderne in ogni momento
monumentali rappresentazioni scultoree (fig. 1). Lo stesso apprezzamento di Vincenzo per
il canto monodico (il "modo di cantare con una voce sola sopra un istrumento"),
testimoniato dai suoi scritti come dalla commissione del nostro Suonatore, ben si accorda
con l'erudizione antiquaria. Anche Giambattista Marino, nella sua rielaborazione del mito
di Orfeo (1620), dedicò numerosi versi alla esaltazione del canto ad una sola voce (cfr.
RUSSANO HANNING [1995], p. 1). La musica, dunque, acquisisce in questo contesto il
carattere di una attività non soltanto virtuosa, ma erudita e tale da implicare
significati ben più profondi del puro intrattenimento. La "liberalità" che
questa arte assume per il marchese Vincenzo è altresì documentata dai numerosi strumenti
musicali che, nell'Amore vittorioso di Caravaggio, si affiancano agli oggetti che
celebrano le doti intellettuali del committente: le armi, i libri, il regolo
dell'architetto, il globo celeste dell'astronomo. Accanto alla tela di Caravaggio, il
Giustiniani possedeva almeno altri due dipinti di analogo soggetto: un Suonatore di liuto
del Pordenone (inv. 1638, II, n. 152; cfr. GARAS [1984]), a noi noto attraverso una
incisione pubblicata dal Landon (LANDON [1812]), ed un Orfeo col violino (più
probabilmente un Omero) di Nicolas Régnier, già conservato a Potsdam accanto al suo
pendant rappresentante un Contadino che canta (inv. 1638, I, nn. 201-202). È evidente,
tuttavia, che il dipinto del Merisi doveva assumere un ruolo particolarmente importante
nella collezione e che per la sua esecuzione il marchese offrì delle indicazioni ben
precise al pittore. È merito di Sir Denis Mahon [1990] l'aver chiarito la storia di
questa opera, erroneamente interpretata dagli studiosi a causa dell'ambiguità di un passo
delle Vite del Baglione relativo alla collezione del cardinal Del Monte: "un giovane,
che sonava il Lauto, che vivo, e vero il tutto parea con una caraffa di fiori piena
d'acqua, che dentro il reflesso d'una finestra eccellentemente si scorgeva con altri
ripercotimenti di quella camera dentra l'acqua, e sopra quei fiori eravi una viva rugiada
con ogni esquisita diligenza finita. E questo (disse) che fu il più bel pezzo, che
facesse mai" (BAGLIONE [1642], p. 136). La dettagliata descrizione della caraffa di
fiori ed il suo apparente collegamento con il Suonatore poco prima menzionato, avevano
indotto in errore gli studiosi che solevano identificare il quadro Del Monte con il
dipinto dell'Ermitage, proveniente invece dalla collezione Giustiniani. Notizie
documentarie relative ad una seconda versione del Suonatore passata da casa Del Monte a
palazzo Barberini (vedi FROMMEL [1971b], p. 36; KIRWIN [1971], p. 55; LAVIN ARONBERG
[1975] ed il fondamentale ritrovamento di WOLFE [1985]) hanno certificato l'esistenza di
due dipinti autografi, molto simili nel soggetto come nelle dimensioni, smentendo
oltretutto il pregiudizio per cui Caravaggio non avrebbe mai eseguito una replica di una
propria creazione. L'incontrovertibilità dei dati documentari è stata successivamente
confermata dall'importante ritrovamento del dipinto Del Monte, oggi conservato a New York
(MAHON [1990]). Come sottolineato da Mahon (MAHON [1990]), la genesi dei due dipinti è
strettamente collegata e si giustifica con il rapporto di amicizia che univa i rispettivi
committenti, mentre l'inserimento della natura morta floreale, alla destra del musico, fu
forse richiesta dallo stesso marchese che aveva potuto ammirare la Caraffa dipinta da
Caravaggio per il cardinal Del Monte. La presenza dei fiori e dei frutti sul ripiano
marmoreo in primo piano, infatti, amplifica il significato erotico-amoroso dell'opera, ma
soddisfa anche l'ammirazione espressa da Vincenzo per l'abilità mostrata dal Merisi nel
dipingere brani di natura morta (di Caravaggio, egli riferisce l'affermazione per cui
"tanta manifattura gli era a fare un quadro di fiori che uno di figure"). Gli
esami riflettografici hanno rivelato (CHRISTIANSEN [1990a]) che l'esemplare Giustiniani fu
certamente il primo ad essere realizzato: inoltre, la particolare finitura che
caratterizza la superficie del dipinto, in modo peraltro assai simile a quella rilevabile
nell'Amor vittorioso, potrebbe essere il frutto delle specifiche richieste del
committente. Le numerose interpretazioni proposte dagli studiosi a proposito del
Suonatore, da quella in chiave omosessuale di Posner (POSNER [1971b]), a quella
cristologica di Calvesi (CALVESI [1990], pp. 216-220), a quella di armonia universale
avanzata da Spezzaferro (SPEZZAFERRO [1971]), concordano nel sottolineare l'aspetto
androgino del giovane musico: una impressione confermata anche dagli inventari più tardi,
come quello del 1793 ove il fanciullo viene così descritto: "una Figura che suona la
Chitarra, per nome detta la Fornarina" (inv. 1793, I, n. 250). La Trinchieri Camiz ha
suggerito di riconoscere nel giovane effigiato il castrato Pedro Montoya, cantore della
Cappella Sistina presente a Roma tra gli anni 1592 e 1600, tentando così di giustificarne
l'ambigua sessualità (TRINCHIERI CAMIZ [1988], p. 172). In merito alla datazione, vi è
ormai una sostanziale concordia critica che propende per gli anni 1595-1596. Infine, è
stato osservato (CHRISTIANSEN [1990b]) che il giovane suonatore ricorda, a causa dei suoi
abiti, i personaggi di taluni poemi di tema pastorale. Il collegamento può trovare
conferma nel fatto che, come risulta dall'inventario della sua biblioteca, Vincenzo
possedeva alcuni drammi di questo genere letterario. L'uso della musica nelle
rappresentazioni sceniche dei drammi pastorali era divenuto, a quest'epoca, assai diffuso
e non è da escludere l'ipotesi che in questo, come in altri casi, Caravaggio o il suo
committente siano stati in qualche modo influenzati dalla pratica teatrale contemporanea
(cfr. CARANDINI [1993]; DANESI SQUARZINA [2000a]). La fama del Suonatore di liuto è
testimoniata, oltre che dalle numerose incisioni che ne furono tratte (MOIR [1976], p. 85,
n. 8), anche dall'elogio riservatogli dal Silos (1673): "Excellentis citharistae
effigies. Eiusdem Caravagij apud eundem". (Irene Baldriga)
Amor Sacro e Amor Profano - Giovanni Baglione
Il quadro è in diretta e complessa relazione con la tela di analogo soggetto, ma di
misure leggermente inferiori (cm 183,4 ¥ 121), conservata nella Gemäldegalerie di
Berlino, proveniente anch'essa dalla collezione Giustiniani (vedi scheda D7). Le prime
notizie relative a due dipinti raffiguranti l'Amor divino eseguiti da Baglione vengono
dalla testimonianza di Orazio Gentileschi nel famoso processo del 1603 intentato da
Baglione contro i suoi denigratori. Dichiara Gentileschi: "...avendo io messo un
quadro di s(an) Michele arcangelo a S. Giovanni de' Fiorentini, lui (Baglione) se mostrò
mio concorrente et ne mise un altro all'incontro, che era un Amor devino che lui aveva
fatto in concorrenza d'un Amor terreno de Michelangelo da Caravaggio; q(ua)le Amor devino
lui l'aveva dedicato al car(dina)le Giustiniano, et sebbene d(ett)o quadro non piacque
quanto quello de Michelangelo, nondimeno per quanto s'intese, esso car(dina)le gli donò
una collana: q(ua)le quadro haveva molte imperfettione, che io gli dissi che haveva fatto
un huomo grande et armato che voleva esser nudo e putto, et così lui ne fece poi un altro
q(ua)le era poi tutto ignudo" (FRIEDLÄNDER [1955], pp. 178 e ss.). Dalle parole di
Gentileschi apprendiamo quindi che Baglione fece due quadri raffiguranti l'Amor divino, il
primo "huomo grande et armato" dedicato al cardinale Giustiniani, il secondo
"tutto ignudo" eseguito, a quanto si può capire, dopo le critiche di Orazio.
Due quadri raffiguranti la Caduta di Lucifero di mano di Baglione sono citati nel 1621
nella galleria grande di Benedetto Giustiniani (DANESI SQUARZINA [1997], pp. 783, n. 38 e
784, n. 54), descritti rispettivamente come: "Un quadro grande de mano del Baglione
della caduta dell Lucifero, con ornamento intorno de pictura" (il quadro in esame) e
"Un quadro della caduta di Lucifero di mano del Baglione, con cornici negre" (la
tela di Berlino, più piccola dell'esemplare romano). La descrizione dei due quadri nel
successivo inventario di Vincenzo Giustiniani del 1638 (SALERNO [1960], I, pp. 185 e 186)
è più accurata: "Un quadro grande d'un amore, simile al suddetto dipinto in tela,
alta palmi 10 lar. 9 in circa con freggi finti di chiaro oscuro, e versi scritti di sotto
di mano del Baglione" (il quadro romano, più grande) e "Un quadro grande d'Amor
virtuoso che calpesta amor lascivo, dipinto in tela, alta palmi 9 lar. 7 in circa con
cornice negra rabbescata d'oro, si crede di mano del Baglioni" (l'opera berlinese).
Occorre notare che le misure delle due tele non coincidono con quelle riportate negli
inventari e aprono un problema al momento non risolvibile; ma, mentre il quadro berlinese
risulta solo essere più stretto di circa 30 cm (palmi 9 ¥ 7 = cm 198 ¥ 154 circa),
quello romano differisce in modo significativo sia in altezza (risulta più alto di circa
20 cm), sia in larghezza (è più stretto di ben 55 cm circa). In questo caso mentre la
minore larghezza è spiegabile con la decurtazione dei fregi di chiaroscuro citati
nell'inventario, meno facile è giustificare la maggiore altezza del quadro in esame
rispetto ai dati del 1638, tanto più che in un'altezza minore erano compresi anche i
"versi scritti di sotto" di mano del pittore ora non più esistenti (o
visibili). Da notare ancora che mentre per il primo dei due dipinti è riportato senza
incertezze il nome di Baglione, per il secondo (più piccolo) nella citazione inventariale
("si crede di mano del Baglione") si può cogliere una sfumatura di dubbio. Sui
due dipinti abbiamo anche la testimonianza dello stesso Baglione, il quale scrive di aver
eseguito per il cardinale Giustiniani due "dipinture di due Amori Divini, che tengono
sotto i piedi l'Amor profano, il Mondo, il Demonio, e la Carne, e queste l'una incontro
all'altra veggonsi nella Sala del Suo Palazzo, dal naturale con diligenza fatte"
(BAGLIONE [1642], p. 403). Sulla base di questi dati VOSS [1922], pp. 60-64, ha attribuito
a Baglione le due versioni dell'Amore vincitore: quella di Berlino (in corazza) e quella
della Galleria Nazionale d'arte antica (senza corazza, con le gambe e le spalle nude),
ritenendo che quest'ultima fosse l'Amore "nudo" dipinto dopo le critiche di
Gentileschi. Non accettano l'ipotesi di Voss, MARTINELLI [1959], pp. 82-96 e SPEAR [1971],
n. 4: Martinelli, in particolare, analizzando la testimonianza di Gentileschi, ritiene che
Baglione dipinse tre quadri di questo soggetto proponendo di identificare l'Amore divino
esposto da Baglione in S. Giovanni dei Fiorentini con la tela oggi a Berlino e l'Amor
divino ("tutto ignudo") con un dipinto in collezione privata romana, e la
versione dipinta per il cardinale Giustiniani con il quadro della Galleria Nazionale.
L'ipotesi di Martinelli non è stata accettata da LONGHI [1963a], il quale ha respinto
l'attribuzione a Baglione del dipinto in collezione privata. L'ipotesi di Voss è stata
invece ripresa da Faldi in ROMA [1970], n. 37 e da RÖTTGEN [1992], pp. 20 e ss.; [1993],
pp. 326 e ss. Röttgen, che data l'esposizione di S. Giovanni decollato (e non "dei
Fiorentini") al 29 agosto 1602, ha identificato nella figura del diavolo a sinistra
un ritratto di Caravaggio e nell'Amore terreno a destra - simile nei tratti all'Amore
vincitore di Caravaggio - quello di Cecco del Caravaggio. Lo studioso ha basato la sua
affermazione soprattutto sulla testimonianza dell'inglese Richard Symonds, che nel
1646-1651, ha riportato come cosa nota che l'Amore vincitore di Caravaggio avesse le
fattezze di Cecco del Caravaggio, servitore e amante del pittore lombardo. La seconda
versione dell'Amore divino è da considerare, secondo Röttgen, una aperta denuncia
dell'omosessualità di Caravaggio, raffigurato qui nel corso di un rapporto sessuale con
colui che era considerato la sua "baldrassa", interrotto dall'apparizione
dall'Amore divino. Rimaste nella collezione Giustiniani fino agli inizi del XIX secolo, le
due tele sono citate nell'inventario del 1802 (inedito, cfr. VODRET [1994], p. 376;
GUARDATA [1997-1998]): una nella galleria con l'attribuzione a Caravaggio, l'altra, come
copia senza nome di autore, in una stanza "dell'appartamento lungo che porta al
Museo". È verosimile che la tela attribuita a Caravaggio, considerata di maggior
valore, sia quella oggi a Berlino, dal momento che è l'unica delle due ad essere
illustrata dal catalogo di vendita di Landon a Parigi del 1812. L'altro Amore vincitore,
considerato una copia, rimase invece a Roma, probabilmente in casa Giustiniani. Nel 1857
compare, con un riferimento a "Maniera di Caravaggio" in uno dei primi cataloghi
del Monte di Pietà (n. 958/1329, p. 57). Con lo stesso riferimento a "Maniera di
Caravaggio L'amore sagro e l'amore profano. Tela alta m. 204 (sic!), larga 143" e con
il valore, non alto, di 1500 lire, compare nel catalogo di vendita del Monte di Pietà del
1875. Nel 1895 è entrato a far parte insieme con numerose altri dipinti, delle collezioni
della Galleria Nazionale. Consegnata in deposito all'Ambasciata d'Italia a Berlino nel
1908, la tela venne dichiarata dispersa in seguito ai bombardamenti del 1944. Dopo il suo
ritrovamento in una collezione privata tedesca, segnalato alla direzione della galleria da
Robert Oertel, direttore dei Musei di Berlino (Faldi in ROMA [1970], p. 88; VODRET [1987],
p. 59), ha fatto ritorno a Roma nel 1969. Durante il restauro del 1979, sotto la roccia a
destra, sono comparse la firma e la data, attualmente poco leggibili per l'ossidazione
delle vernici. Nella stessa occasione è emerso che la gamba nuda in primo piano era
coperta inizialmente da un calzare con decorazioni in metallo sbalzato (Magnanimi in ROMA
[1982], n. 25). Resta misterioso il motivo per cui Baglione sentì il bisogno di firmare e
datare la seconda versione del dipinto e non la prima eseguita, stando alle parole di
Gentileschi, per il cardinale Giustiniani e che doveva verosimilmente rivestire per il
pittore un'importanza maggiore della seconda. Importanza che, come si è visto, viene
riconosciuta anche negli inventari Giustiniani del XIX secolo, dove la seconda versione,
nonostante la presenza della firma, è citata come copia. (Rossella Vodret)
Amor Sacro e Amor Profano - Giovanni Baglione
Giovanni Baglione, uno dei protagonisti della scena pittorica romana, svolse un
ruolo importante sin dagli anni del tardo Manierismo romano, in rapporto con i seguaci di
Barocci e con il Cavalier d'Arpino e con incarichi nei maggiori cantieri papali. I suoi
scritti (BAGLIONE [1639]; [1642]) sono preziosi punti di riferimento per la storiografia
artistica. In quest'opera l'artista mostra la volontà di abbandonare il suo iniziale
linguaggio e di emulare la pittura di Caravaggio; la grande figura alata ha un viso e una
capigliatura da androgino, come il Suonatore di liuto, mentre nella resa delle piume, nei
riflessi metallici della corazza, nella attenzione ai particolari più minuti come le
piccole borchie e cerniere, o nel sottile bordo rosso e bianco che delinea la scollatura,
nella consistenza dei materiali e delle epidermidi, nel piede nudo da popolano, posto bene
in vista, emerge una intenzione di aderenza naturalistica al vero, che delinea una fase
nuova dell'artista, un modo di dipingere che lui riassumerà in seguito nei suoi scritti
con una frase inequivocabile: "Dal naturale, con diligenza fatti" (BAGLIONE
[1642], p. 403). Questa pronta emulazione, peraltro superficiale e priva di spessore
intellettuale, che avveniva quasi in sincronia col mutare del modo di dipingere del
Merisi, sincronia resa possibile dalla stretta frequentazione degli stessi committenti,
certamente irritò colui che veniva imitato e fu la causa degli anonimi versi derisori che
provocarono una denuncia e un processo. Baglione vide la sua rispettabilità messa in
forse da un gruppo di pittori, Orazio Gentileschi, Onorio Longhi e Filippo Trisegno,
egemonizzati dal Merisi, e li denunciò tutti e quattro, provocandone l'arresto e
l'interrogatorio, i cui verbali rappresentano una fonte utilissima per datare questo
dipinto nonché l'Amore vincitore di Caravaggio (BERTOLOTTI [1881], vol. II, pp. 51-64;
VOSS [1922], p. 60 e ss.; [1923], pp. 95 e ss.; SAMEK LUDOVICI [1956], pp. 145-165). Il
titolo stesso del dipinto, Amor sacro, ovvero divino, è una proiezione dell'ambigua e ben
più famosa raffigurazione offerta da Caravaggio ai Giustiniani. Ora che disponiamo anche
degli inventari del cardinale Benedetto (DANESI SQUARZINA [1997], pp. 783-784, nn. 38, 54)
possiamo arguire che il gagliardo giovane alato, con in mano una divina saetta, è un S.
Michele Arcangelo, in quanto, tradizionalmente, a lui, domatore degli spiriti inferiori,
è delegata "la caduta di Lucifero" di cui parla l'inventario del 1621, un po'
più vicino alla memoria dei fatti, rispetto a quello del 1638. Dobbiamo quindi dar fede a
Gentileschi il quale dichiara nella deposizione al processo "avend'io messo un quadro
di S. Michele Arcangelo […] lui se mostrò mio concorrente"; è vero anche che
il quadro Baglione "l'aveva dedicato al Cardinale Giustiniano" e infatti è
Benedetto che tiene i due dipinti, quasi uguali, del Baglione, appesi nella Galleria.
Nelle parole di Gentileschi "et se bene dicto quadro non piacque quanto quello di
Michelangelo, nondimeno per quanto s'intese, esso cardinale gli donò una
collana…"; il dono suona come una consolazione. Il quadro, che ci conduce nel
pieno delle rivalità e delle risse tra artisti, ha una sua qualità e autorevolezza ed è
una delle opere migliori della fase caravaggista del Baglione, fase che terminerà pochi
anni dopo; si avverte la sicurezza e il piglio del frescante nell'ampio gestire
dell'arcangelo, e nella sua dimensione, che occupa l'intero spazio della tela ed è fatto
per essere visto bene anche da lontano. Per proseguire nella definizione dell'iconografia
(che può avere come riferimento S. Michele che sconfigge Satana di Raffaello, Parigi,
Louvre) ricorriamo di nuovo alle parole del suo autore (BAGLIONE [1642], p. 403); sotto il
piede che abbiamo definito da popolano, giacciono "...il Mondo, il demonio, la
carne", quindi a terra, seminudo, con nella destra l'arco e nella sinistra le frecce
spezzate, e segnate di rosso (come una delle due frecce dell'Amore Vincitore di
Caravaggio) giace l'amore profano ossia l'amore carnale che S. Michele Arcangelo protegge
e separa dal demonio che stringe una forca. Il contrasto fra l'oscurità del fondo e la
luminosità del primo piano è giustificato dall'ambientazione: è in una sorta di caverna
infernale, con asperità rocciose, che si svolge lo scontro fra il bene e il male. Lo
stesso Baglione dice inoltre: "Et al Cardinal Giustiniani fece due dipinture di due
Amori Divini". La tela di Berlino, qui esaminata, dovrebbe essere immediatamente
anteriore a quella conservata a palazzo Barberini, firmata e datata 1602 (Magnanimi in
ROMA [1982]) in cui S. Michele ha le gambe nude (un pentimento ha eliminato un elaborato
calzare), forse per aderire all'invito di Gentileschi, che Amore dovrebbe "esser nudo
e putto" e non "un huomo grande et armato". Fu VOSS [1923], pp. 96-97, a
identificare la seconda versione del dipinto con un quadro proveniente dal Monte di Pietà
di Roma (cataloghi del 1857 e 1875) e nel 1895 assegnato alla Galleria Nazionale d'Arte
Antica, poi all'Ambasciata Italiana a Berlino, poi trafugato, e ora di nuovo a Roma,
palazzo Barberini, Galleria Nazionale d'Arte Antica, inv. 1268 . I due quadri non avevano
dimensioni identiche; la presunta seconda versione misurava dieci palmi per nove (contro i
nove per sette della berlinese) e aveva, secondo l'inventario del 1638, "un freggio
finto di chiaroscuro e versi scritti di sotto" che dobbiamo ipotizzare rifilati, per
vederla corrispondere, anche se non perfettamente, con le misure della tela di palazzo
Barberini. Sono entrambe citate, con identica descrizione e identiche dimensioni, sette
palmi per dieci, in palazzo Giustiniani, nell'inventario dei "quadri di buoni
autori", 1793, I, una al n. 96, come opera di Caravaggio e posta accanto al S. Matteo
con l'angelo del Merisi, l'altra al n. 274 come "copia di Caravaggio";
riappaiono, anche lì separate, nell'inventario delle assegne, del 1802 (vedi VODRET
[1994], p. 376; DANESI SQUARZINA [2001]); quella di Berlino è la sola versione a
comparire nei cataloghi PAILLET-DELAROCHE [s.d. (1808)], DELAROCHE [1812] e LANDON [1812].
Il dipinto fu attribuito al Baglione da Longhi verbalmente nel 1920, vedi LONGHI [1943],
p. 41, nota 28, e da VOSS [1922], che segnalava l'esistenza di una replica presso
l'Ambasciata d'Italia a Berlino (vedi scheda n. ### in questo stesso catalogo).
L'autenticità dell'opera è ormai riconosciuta universalmente, così come la sua
identificazione con la prima versione dell'amore divino eseguita dal Baglione per
Benedetto Giustiniani. MARTINELLI [1959], p. 95, pensa che il dipinto fu eseguito per una
cappella in S. Giovanni dei Fiorentini, ma si confonde con la ben nota esposizione a S.
Giovanni Decollato, anch'essa chiesa dei "Fiorentini" (da datare al 29 agosto
1602, RÖTTGEN [1992], pp. 20 e ss.; [1993], pp. 326 e ss.). In tal modo, egli sposta la
cronologia del dipinto, ritenendo la versione di Berlino come la seconda e non come quella
eseguita da Baglione per il cardinale Benedetto, in concorrenza con Caravaggio. Lo stesso
Martinelli afferma che il primo amore divino fu eseguito al più tardi agli inizi del
1602, giacché intorno a quella data Baglione afferma di essere stato schernito da
Gentileschi per via della collana donatagli da Benedetto. Nella tela di Berlino il viso
del diavolo è nascosto, mentre è visibile in quella di Roma; Röttgen vi riconosce le
sembianze di Caravaggio e una pesante allusione alla sua presunta omosessualità. Per
l'esistenza di una versione dell'"amore tutto nudo" del Baglione in collezione
privata, ipotizzata da MARTINELLI [1959], e rifiutata da LONGHI [1963], pp. 23-31,
riconsiderata da Vodret in ROMA [1999a], p. 32, n. 4, vedi la scheda successiva. Per il
rapporto con la Psicomachia di Prudenzio e per il tema di eros e anteros vedi Cola in
LECCE [1996], pp. 189-190, con bibliografia precedente. Ringrazio Erich Schleier di aver
messo a mia disposizione la documentazione radiografica; il montaggio delle lastre, qui
pubblicato per la prima volta, mostra un vistoso pentimento nel braccio dell'arcangelo che
stringe il dardo infuocato; in prima stesura il braccio era leggermente più flesso.
(Silvia Danesi Squarzina)
Ritratto di un uomo - Jusepe Ribera
Il dipinto appare nel catalogo del museo berlinese come opera di artista
romano-napoletano (GESAMTVERZEICHNIS [1996]), mentre nei cataloghi precedenti fino ai
primi anni del Novecento era riportata l'attribuzione a Caravaggio. Successivamente, il
dipinto, in prestito a Düsseldorf, fu pressoché dimenticato. SALERNO ([1960], p.135),
che fa riferimento ad una riproduzione fotografica, osserva che la veste dell'effigiato
appare ridipinta e comunque leggermente differente dall'incisione riprodotta nel Landon;
lo studioso, pur con dubbi circa l'assegnazione a Caravaggio, identifica il dipinto qui
esposto con il ritratto del pittore tedesco Sigismondo Laire, menzionato nell'inventario
di Vincenzo Giustiniani al numero II, 6 ("Un'altro quadro con un ritratto di Gismondo
Tedesco Pittore dipinto in tela da testa [di mano di Michelangelo da Caravaggio] con sua
Cornice nera profilata d'oro"). Dubbi sull'attribuzione al Merisi, nonché sulla
identificazione dell'effigiato sono stati espressi dagli studiosi in numerose occasioni:
così Longhi, che riteneva di riconoscere nel dipinto quello descritto dal Silos, ma si
esprimeva in favore di una attribuzione a Orazio Gentileschi (LONGHI [1916], pp. 267,
311); la Cinotti si è dichiarata contraria ad associare la fisionomia del personaggio a
quella del pittore nordico (CINOTTI [1983], p. 558). Più recentemente, una ulteriore
proposta è stata avanzata da Antonio Vannugli, il quale ha escluso che il dipinto di
Berlino possa essere quello menzionato nell'inventario di Vincenzo Giustiniani, descritto
anche dal Silos (VANNUGLI [1985]). In sintesi, non vi sono dubbi che l'opera non è di
Caravaggio, mentre resta indiscutibile la provenienza Giustiniani, ma anche
l'identificazione come Sigismondo Laire, per incongruenze fra l'età del ritrattato (Laire
muore nel 1629 a 86 anni, cfr. BAGLIONE [1642], pp. 353-354) e l'epoca presumibile del
dipinto (CINOTTI [1983], p. 558) è stata, e rimane, oggetto di discussione. La fisionomia
di Laire nella incisione di Leoni titolata Li sicari è anch'essa incerta poiché
suggerita da fonte non contemporanea, il Mariette, per cui non può giovare come confronto
certo (VANNUGLI [1985], p. 17). Caravaggio conosceva Laire personalmente e infatti lo
menziona nel famoso interrogatorio (BERTOLOTTI [1881], vol. II, p. 58; SAMEK LUDOVICI
[1957], pp. 150 e ss.). Benché venga attestato sia dall'inventario del 1638, II, 6, sia
dal SILOS [1673], p. 89, non possiamo sapere se sia mai effettivamente esistito un
ritratto di Gismondo tedesco eseguito dal Merisi, e poi perduto e rimpiazzato per errore
nelle inventariazioni moderne (Delaroche e Landon) dal dipinto oggi a Berlino. Su
quest'ultimo, di innegabile qualità, si sono esercitati gli studiosi con discordanti
attribuzioni. Il nome di Ribera è stato proposto da Pérez Sánchez e Spinosa (SPINOSA
[1978]). Dopo il restauro del 1980, diretto da Erich Schleier, riferisce la Cinotti
(CINOTTI [1983], p. 558, n. 74 e p. 576, n. 141) che l'attribuzione a Ribera venne
respinta da Raffaello Causa e da Craig Felton di Forth Worth (comunicazioni verbali),
mentre Salerno (comunicazione scritta) stabilisce che non è assolutamente di Caravaggio;
"un curioso 'romanticismo' seicentesco, consiglierebbe di approfondire l'ipotesi
francese del Longhi esplorando meglio la cerchia attorno a Valentin, Régnier, Maestro del
Giudizio di Salomone"; strano che Vincenzo, nella "stanza dei quadri
antichi", con le gemme della collezione metta un quadro dubbio "probabilmente
non è quello dell'inventario, che andò disperso prima della vendita parigina".
L'esistenza di repliche del dipinto di Berlino, ma di maggiori dimensioni, è documentata
da almeno due esempi: il primo, di collocazione sconosciuta, pubblicato da Antonio
Vannugli (su segnalazione di Maurizio Marini, cfr. MARINI [1974], p. 480), in cui il
personaggio è ritratto a mezzo busto (VANNUGLI [1985], tav. II); il secondo, conservato
presso la Galleria Regionale della Sicilia, Palermo, donato nel 1992 da don Gabriele
Ortolani, barone di Bardonaro, principe di Torremuzza (ai Torremuzza apparteneva l'album
di Castello, per cui vedi scheda A3) e presentato alla mostra Porto di Mare (Spinosa in
PALERMO [1999], p. 210). Il dipinto di Palermo mostra il personaggio in controparte
rispetto a quello di Berlino e a quello pubblicato da Vannugli; egli guarda verso destra e
sfoglia il libro che ha davanti, non impugna la penna che giace in primo piano sul tavolo;
a destra, rivelata dal recente restauro, la mitra vescovile; tre dati iconografici che
hanno consentito a Abbate e Spinosa di identificare l'opera, di indubbio livello, come un
S. Agostino. Fra i numerosi dipinti che l'inventario Giustiniani del 1638 attribuisce a
Spagnoletto vi è anche un S. Agostino, elencato con altri tre dottori della Chiesa
nell'anticamera dell'appartamento grande del cardinale (1638, II, nn. 141-144), il
formato, tela d'imperatore, ha certo rispondenza con il dipinto di Palermo, ma non è
possibile dire di più, per mancanza di dati ulteriori. Peraltro non conosciamo a fondo le
caratteristiche del periodo romano dell'artista; indubbiamente il piccolo gruppo di opere
riferite agli esordi di Ribera, discusse da Milicua in NAPOLI [1992], pp. 17-30, o alla
primissima fase dell'insediamento a Napoli ci mostrano un artista che ha già elaborato un
personale linguaggio, e che fa della conoscenza delle opere di Caravaggio un uso mirato
verso l'intensità psicologica degli sguardi, esaltati dalla luce dall'alto, volti che
escono dal buio, teste appena ruotate all'indietro, un incipiente ma ancora moderato
patetismo. Sia il S. Filippo (Roma, collezione privata, NAPOLI [1992], p. 124, fig. 1.7a)
che il S. Paolo (Napoli, Quadreria dei Gerolamini, NAPOLI [1992], p. 121, fig. 1.6c),
formati di "tela da testa" in cui il santo è inquadrato poco sotto le spalle e
la luce batte sulla fronte e sugli zigomi, presentano affinità strutturali con il dipinto
di Berlino; le due repliche di quest'ultimo, in maggiore formato, già citate, quella di
ubicazione ignota e quella di Palermo, danno un completamento iconografico che diviene
sigla stilistica più evidente, e consentendoci di ampliare la comprensione
dell'enigmatico dipinto ci induce ancora in direzione di una koiné caravaggesca a cui
contribuiscono Baburen al pari di Ribera; ma è in quest'ultimo, in opere a lui
attribuite, come la serie dei Cinque sensi (LONGHI [1966]; SCHLEIER [1968b]) che troviamo
ricorrente, quasi una formula tipica, il piano di appoggio su cui sta il libro che taglia
la figura all'altezza della vita; peculiare risulta anche il leggero gonfiore delle dita
della mani e la pelle tesa sottolineata da piccoli colpi di luce. Fra Baburen e Ribera
sembrano esservi contatti e scambi; andrebbe verificata la vecchia attribuzione
all'olandese di copie di due delle tele dei Cinque sensi dello spagnolo (Vienna,
Dorotheum, cfr. SPINOSA [1978], p. 92, figg. 2a, 3a). Forse le vicinanze furono facilitate
dalla comune frequentazione dei Giustiniani. Le differenze sono nei toni dominanti e nel
tipo di preparazione usata sulla tela, più rossastra quella di Baburen; toni più verso
il marrone giallastro nelle opere di Ribera riferibili alla parentesi romana. Si veda ad
esempio il Democrito (Londra, collezione privata, NAPOLI [1992], p. 121, fig. 1.5) o il
Geografo sorridente (Montecarlo, collezione Piero Corsini). Nella rielaborazione
dell'eredità di Caravaggio, punti di contatto fra Ribera e Valentin, nome avanzato anche
dalla Cinotti (CINOTTI [1983]), sono costituiti dalla citazione di frammenti scultorei,
presenti nel Tatto e ai piedi del S. Bartolomeo martirizzato (Roma, Galleria Pallavicini).
Dunque è necessario riconoscere al soggiorno romano di Ribera uno sperimentalismo di
linguaggio, forse accentuato da collaboratori per ora non identificati, che cederà il
posto, su sollecitazione della committenza napoletana, a una pittura più conseguente alle
sue origini spagnole. Certo sapremmo assai di più sul soggiorno di Ribera se ci fossero
pervenute le numerose opere elencate nell'inventario del 1638, ben tredici, di cui una
sola passata alla vendita parigina (LANDON [1812], p. 143, fig. 88; VERZEICHNISS [1826],
n. 135, opera perduta) raffigurante Archimede che guarda in uno specchio, e che ci lascia
intravedere un interesse per l'ottica che sta alla base anche del dipinto La vista (Città
del Messico, Museo Franz Mayer) secondo Mancini (MANCINI [1617-1621, ed. 1956-1957])
dipinto per uno spagnolo. Non sappiamo molto sulle presenze spagnole a Roma, sul fratello
di Ribera, sul "Gris spagnuolo" di cui parla Giustiniani per cui non è
possibile giungere a conclusioni più consistenti. L'unico suggerimento ulteriore da
aggiungere alla discussione è il documento integralmente trascritto da GALLO [1998], pp.
333-334 che anticipa la presenza di Ribera a Roma al 1613 (vedi però anche Milicua in
NAPOLI [1992], pp. 17-29, 24, 29, nota 2, nonché HOOGEWERFF [1913], vol. II, pp. 107-108,
n. XXXVIII) ove si legge come il Ribera venga convocato a una "congregazione"
dietro invito dell'Accademia di S. Luca, insieme a numerosi artisti, fra cui Sigismondo
Laire, forse non così vecchio come dice BAGLIONE [1942], pp. 353-354; è poi da
sottolineare una traccia di inserimento del tedesco Laire nell'ambiente spagnolo (CHECA
[1985], p. 236, citato da GALLO [1998], p. 334). Per quanto Mancini scrive del Ribera
vedi, oltre all'edizione degli scritti (MANCINI [1617-1621, ed. 1956-1957]), pp. 249-250),
anche MACCHERINI [1997], pp. 71-92, discusso in GALLO [1998], p. 328. Per una organica
trattazione della produzione dell'artista spagnolo vedi in NAPOLI [1992], i saggi e le
schede di Alfonso E. Pérez Sánchez e di Nicola Spinosa. (Silvia Danesi Squarzina)
La preghiera del figliol prodigo - Angelo Caroselli
L'attribuzione a Caroselli è stata proposta dalla Giffi, in base al confronto
con la figura del profeta David dipinta dall'artista nella cappella della Pietà di S.
Maria in Vallicella: la tipologia morfologica dei personaggi rappresentati nelle due opere
e lo studio luministico affine sembrano accreditare tale ipotesi (GIFFI [1986], p. 26). La
datazione avanzata dalla studiosa si aggancia alla esecuzione di un dipinto di Pietro
Paolini, il Santo Guerriero, avvenuta negli anni 1625-1626. Precedentemente, il dipinto
era stato attribuito a Lanfranco da Federico Zeri, che ne aveva proposto il confronto con
il S. Andrea di Berlino e con il S. Carlo Borromeo della Galleria Colonna. Ribadita da
VOLPE [1980], p. 44, e spostata ad un "pittore affine a Lanfranco" da BERNINI
[1986], p. 56, l'attribuzione al parmense è rimasta condivisa fino all'intervento della
Giffi. Non vi è dubbio che l'opera vada collocata nell'ambito della fase caravaggesca di
Angelo Caroselli, ricordato dal Baldinucci per il suo modo di dipingere nella "totale
imitazione" dello stile del Merisi. La sua identificazione con il dipinto menzionato
negli inventari Giustiniani del 1638 e del 1793 appare convincente: benché le misure
siano leggermente discordanti la descrizione dell'iconografia sembra collimare con il
quadro di palazzo Spada. Il soggetto del dipinto corrisponde ad un passo della parabola
del figliol prodigo (Vangelo di Luca, 15,11); qui, il giovane è rappresentato nel momento
della massima abiezione, quando, seminudo, si abbandona alla stanchezza in mezzo a un
porcile. L'iconografia del figliol prodigo, ampiamente diffusa in area nordica sin dal
Medioevo, ottiene una rinnovata attenzione per effetto del movimento riformistico (HAEGER
[1986a] e [1986b]). La parabola dei due fratelli si collega al tema cruciale della
concessione della grazia, e per questa ragione suscitò interpretazioni molto diverse in
area cattolica e protestante. La divergenza fondamentale riscontrabile nelle esegesi
proposte dai due fronti teologici riguarda proprio il motivo per cui il giovane ottiene il
perdono; Lutero e Calvino erano concordi nel negare all'uomo la possibilità di
partecipare con le proprie azioni al processo della Redenzione. Nel commentare la parabola
del figliol prodigo Calvino contesta esplicitamente il punto di vista cattolico per cui il
giovane ottiene il perdono in seguito all'ammissione della propria colpa e, dunque, al
pentimento. Concentrandosi sull'episodio del porcile, il dipinto di Caroselli appare come
un autentico emblema dell'interpretazione di parte cattolica: il giovane alza gli occhi al
cielo chiedendo perdono per i propri peccati. È questo il nodo essenziale che dà senso
all'intera parabola evangelica. Il bagliore sullo sfondo del paesaggio e la luce
sovrannaturale che illumina il corpo del ragazzo alludono alla grazia divina. Probabile
prototipo dell'impostazione, in chiave "penitenziale", adottata da Caroselli è
la celebre incisione di Dürer (1496 circa), ove il giovane dissoluto è rappresentato in
ginocchio, con le mani giunte, in chiaro atteggiamento di contrizione; una creazione tanto
famosa e riprodotta, da essere elogiata anche da Vasari (cfr. PANOFSKY [1983], p. 102;
PARIS [1996], pp. 76-77, n. 32). La scelta compositiva che sottende alla esecuzione del
dipinto Giustiniani meriterebbe comunque ulteriori approfondimenti, soprattutto perché
essa lascia supporre una precisa indicazione da parte del committente; il tema del figliol
prodigo, infatti, ampiamente diffuso ancora nel Seicento, viaggia in area caravaggesca
contaminandosi con il genere delle scene di giocatori di carte o di bevitori. In altri
contesti si concentra piuttosto sull'episodio del ritorno e sul lieto fine dell'avventura
del giovane che si era mostrato irriverente nei confronti dell'autorità paterna. In
merito all'influenza esercitata da Vincenzo Giustiniani sulla evoluzione stilistica di
Caroselli si è soffermato, in particolare, SALERNO [1992], p. 351. Non soltanto
l'autorevolezza del marchese e la sua abilità di esperto e coraggioso collezionista
poterono indirizzare gli esordi dell'artista verso il naturalismo caravaggesco, ma indurlo
in seguito ad aderire alla svolta classicista che prese il sopravvento a partire dagli
anni Trenta. L'inventario del 1638 elenca altri dipinti del pittore, che suggeriscono
ulteriori considerazioni sulla natura del rapporto che poté stabilirsi tra Caroselli e il
Giustiniani (MOIR [1967], vol. I, p. 54). Oltre all'opera qui esposta, tra i beni del
marchese vengono annoverati una copia, in dimensioni ridotte, del S. Matteo di Caravaggio,
forse della prima versione già posseduta dai Giustiniani (1638, II, n. 233), nonché il
celebre Pigmalione (perduto), commissionato da Vincenzo quale celebrazione della Galleria
Giustiniana. Ciò che maggiormente interessa, a mio giudizio, è la presenza, quanto mai
densa di implicazioni, della replica del S. Matteo. Sappiamo dalle fonti che il Caroselli
si venne affermando principalmente come copista e in alcuni casi persino come inimitabile
contraffattore di opere d'arte: la sua abilità di imitatore degli antichi maestri fu tale
da ingannare lo stesso Poussin, che non fu in grado di distinguere una sua copia di una
Vergine di Raffaello dall'originale. A quanto ci dice il Baldinucci, Caroselli
"…ebbe un particolare talento a far apparire a stupore tutte quelle macchie, e
quella stessa pelle, e patina come dicono i pittori che suol fare il tempo sopra l'antiche
pitture"; tali affermazioni si prestano a descrivere l'opera di un falsario, più che
quella di un semplice e diligente copista e inducono a ritenere che l'artista svolse un
ruolo significativo nel fervente mercato delle repliche attivo a Roma già in quegli anni.
Nell'inventario del 1638 vengono menzionate non meno di sedici copie, in gran parte tratte
dagli "antichi maestri", particolarmente Tiziano, Raffaello e Giorgione, ma in
alcuni casi, come quello del S. Matteo, derivate proprio dai prototipi conservati nel
palazzo. Dell'uso che si faceva di queste copie, per l'esecuzione delle quali - questo è
certo - era necessaria l'esplicita autorizzazione dei proprietari, non sappiamo granché,
ma di certo era questa una delle fonti più importanti alle quali poteva attingere il
mercato dell'epoca. Si consideri, ad esempio, l'enorme quantità di repliche che furono
eseguite (presumibilmente su licenza del cardinale Benedetto) dall'Incredulità di S.
Tommaso del Caravaggio (MOIR [1976] pp. 89-90, 127, note 190-192). Replicare un dipinto
significava, secondo il Mancini, "sverginarlo" diminuendone così il valore
commerciale (MACCHERINI [1987]); un processo che doveva certo implicare una contropartita
per il proprietario. Se le notizie riportate dal Baldinucci in merito all'abilità del
Caroselli corrispondono al vero, non possiamo dubitare del fatto che il marchese Vincenzo
volle in qualche modo avvalersene, giacché, nel suo Discorso sopra la pittura, egli dà
prova di apprezzare le qualità del buon copista con parole che lo accomunano al falsario:
"…e quanto più eccellente sarà il pittore, purché abbia pazienza, tanto
migliore riuscirà la copia, a segno che talvolta non sarà conosciuta dall'originale, e
talvolta anco lo supererà; che, all'incontro, se il copiatore sarà inesperto, e di poco
spirito, sarà facilmente conosciuta la differenza dell'originale dalla copia"
(GIUSTINIANI [s.d., ed. 1981], p. 41). (Irene Baldriga)
La cena in Emmaus - Nicolas Regner
Nicolas Régnier, conosciuto in Italia con il nome di Nicolò Renieri, ebbe il
privilegio di essere accolto presso palazzo Giustiniani in qualità di "pittore
domestico"; in base a quanto ci è noto, il marchese Vincenzo fu l’unico
mecenate che si occupò dell’artista durante il suo soggiorno romano
(1610/1620?-1626). Secondo il suo biografo, Joachim von Sandrart, Régnier si sarebbe
affermato nella città pontificia come adepto della Manfrediana Methodus ed in qualità di
pittore attivo presso casa Giustiniani (SANDRART [1675, ed. 1925], p. 368). Residente nel
palazzo del suo protettore, in piazza S. Luigi dei Francesi (forse fra il 1622 e il 1623),
l’artista realizzò, secondo Sandrart, "dei quadri con mezze figure,
rappresentanti consessi di giocatori, ma anche quadri religiosi e profani eseguiti da
modelli viventi" (SANDRART [1675, ed. 1925], p. 368). Una scelta stilistica così
precisa in favore della cosiddetta "pittura al naturale", cioè per la
rappresentazione di figure "eseguite da modelli viventi", non deve sorprendere
da parte di un artista attivo presso uno dei più grandi estimatori di Caravaggio.
L’inventario post mortem del marchese (1638) conferma la testimonianza di Sandrart:
Régnier vi è infatti menzionato come autore di nove dipinti, fra i quali quattro tele
monumentali di soggetto religioso, e vi appare come uno degli artisti meglio rappresentati
di tutta la collezione. Queste nove tele, che sono inoltre le sole opere certe di tutta la
sua carriera romana, mostrano differenti generi pittorici: il ritratto, la scena di genere
(i consessi di giocatori citati da Sandrart risultano, tuttavia, assenti), la mitologia e
la storia sacra. Soltanto quattro di questi dipinti possono essere oggi identificati con
un certo margine di certezza: la Cena in Emmaus di Potsdam è l’unica opera di
Régnier appartenente alla collezione Giustiniani oggi conservata e sulla quale la
storiografia critica non ha sollevato alcun dubbio (SALERNO [1960], p. 94, n. 3); per il
S. Giovanni Battista nel deserto, il Bacco e l’Omero cieco che suona il violino, le
identificazioni sono invece più problematiche (SALERNO [1960], p. 102, n. 173; p. 103,
nn. 203, 201). La provenienza Giustiniani di queste tele è ben documentata; già esposte
a Potsdam esse sono andate perdute alla fine della seconda guerra mondiale. Comprati a
Parigi nel 1815 dal re di Prussia Federico Guglielmo III, insieme alla Cena in Emmaus, i
dipinti furono tradotti in incisioni e quindi pubblicati nel catalogo del Landon: la Cena
in Emmaus fu in quell’occasione attribuita a Bartolomeo Manfredi (fig. 1), mentre le
altre due tele venivano ancora assegnate a Régnier (LANDON [1812], p. 39, tav. 16; p.
143, tav. 68; p. 133, tav. 63). Ad oggi si conserva una sola foto del Bacco (fig. 2),
mentre l’Omero, conosciuto soltanto tramite l’incisione del XIX secolo, potrebbe
corrispondere ad un dipinto inedito comparso sul mercato parigino, le cui dimensioni
corrispondono a quelle citate nell’inventario post mortem del marchese Vincenzo
Giustiniani (fig. 3) (LEMOINE [2000c]). Infine, un S. Giovanni Battista nel deserto (fig.
4), recentemente attribuito a Nicolas Régnier, già in una collezione privata napoletana,
ma attualmente di ubicazione ignota, potrebbe essere il "quadro grande di S. Giovanni
Battista nel deserto" esposto nella settima sala dell’appartamento di Benedetto
Giustiniani (LEMOINE [2000a], in corso di stampa). Di quest’opera si conosce soltanto
l’immagine fotografica, conservata presso la fototeca della Fondazione di Studi
Roberto Longhi e dell’Istituto Universitario olandese di Firenze. Le altre cinque
tele dipinte da Régnier per il suo protettore sono oggi note solo attraverso le
descrizioni fornite dall’inventario di Vincenzo: una copia della "Madalena
figura intiera" di Caravaggio, che all’epoca apparteneva al marchese (inv. 1638,
II, n. 7); un S. Matteo (esposto con il S. Giovanni Battista nel deserto); un Contadino
che canta (pendant dell’Omero cieco che suona il violino); e, infine, il Ritratto del
marchese Vincenzo Giustiniani e l’Autoritratto di Régnier, entrambi inventariati
nella "Guardaroba" (SALERNO [1960], p. 101, n. 155; p. 102, n. 171; p. 103, n.
202; p. 147, nn. 259, 260). Fra le opere di Nicolas Régnier possedute dal marchese,
sembra che i quadri religiosi godessero di una considerazione particolare; questa
impressione viene suggerita tanto dal formato (si passa dalla tela d’imperatore alle
dimensioni della pala d’altare) quanto dalla collocazione riservata ai dipinti
all’interno del palazzo. Non vi è dubbio che, tra tutte, la Cena in Emmaus svolgesse
un ruolo di eccezione. Si tratta di una composizione molto importante, un grandioso quadro
di storia con molte figure; il più grande dipinto realizzato da Régnier durante la sua
permanenza a Roma. Nel 1638 la Cena in Emmaus decorava la "sala grande
dell’appartamento nobile", ossia la "sala dei palafrenieri", ornata
inoltre da quattro colonne, da sculture antiche e da un gruppo marmoreo
"moderno", un Cristo bambino con S. Giovanni Battista. Nove altri quadri con
soggetto sacro vi erano esposti insieme a quello di Régnier. Di dimensioni simili, queste
opere furono eseguite da artisti contemporanei al nostro, cinque dei quali erano nordici:
Cornelis Schut, il misterioso "Antonietto fiammingo" (non identificabile con
certezza), Nicolas Régnier, così come due suoi amici e colleghi, adepti anche loro della
"pittura al naturale", David de Haen e Valentin de Boulogne. Anche se la genesi
della decorazione del salone citato resta difficile da ricostruire (LEMOINE [2000c]), è
però assai probabile che questi grandi quadri di storia costituissero per i loro autori,
in gran parte giovani artisti, una sorta di "morceau de réception", ovvero una
prova decisiva nella loro carriera. Affrontando un tema caro a Caravaggio, Régnier sembra
aver concepito la sua composizione come un esercizio di stile ispirato alle due celebri
Cene in Emmaus del pittore lombardo, entrambe visibili a Roma a partire dal 1606 (oggi
conservate presso la National Gallery di Londra e presso la Pinacoteca di Brera di
Milano). C’è da chiedersi se tale scelta possa riflettere il gusto specifico del
committente. Come Caravaggio, Régnier ha dipinto il momento della benedizione (Luca,
XXIV, 30-31): rinnovando il gesto dell’Eucarestia, Cristo risorto appare ai suoi
discepoli. Il vino e il pane, simboli della Redenzione, completano il senso della
composizione. Le citazioni caravaggesche sono numerose. L’estrema semplicità della
scena, i gesti espressivi dei discepoli che mostrano il proprio stupore, ma anche la
disposizione della tovaglia e la natura morta, richiamano con evidenza la Cena in Emmaus
di Caravaggio della National Gallery di Londra. L’uso del fondo scuro evoca invece la
versione di Brera. Il dettaglio dei piedi nudi dell’uomo anziano è ispirato al S.
Matteo e l’angelo di Caravaggio, quadro che all’epoca apparteneva allo stesso
Giustiniani (SALERNO [1960], p. 135, n. 1). Inoltre, la sedia savonarola, sulla quale si
appoggia il pellegrino, era un accessorio caratteristico dell’arredamento
dell’epoca; la ritroviamo in un’altra opera di Régnier, il S. Luca del Musée
des Beaux-Arts di Rouen, ma anche in vari dipinti di Caravaggio, o ancora in Manfredi,
nell’Apparizione di Cristo alla Vergine dopo la Resurrezione (vedi la scheda di Mina
Gregori in questo stesso catalogo), una delle tre tele dell’artista allora esposte in
palazzo Giustiniani (SALERNO [1960], p. 101, n. 135), oggi conservata al Museo Civico Ala
Ponzone di Cremona. Infine, il linguaggio espressivo delle mani, accentuato dal gioco
della luce, costituisce uno dei temi caratteristici del lessico figurativo caro ai seguaci
del naturalismo: la mano in controluce del pellegrino di sinistra, ad esempio, sembra
quasi identica a quella di uno dei testimoni della Vestizione di S. Francesco di Simon
Vouet, conservato in S. Lorenzo in Lucina. L’attribuzione dell’opera a Régnier
è accettata unanimemente, sia per l’ispirazione alle composizioni romane di
Caravaggio, sia per i drappeggi, la fattura e i dettagli o, ancora, per la tipologia dei
personaggi. Malgrado ciò, nel 1812, Landon e Delaroche pubblicarono il quadro come opera
di Bartolomeo Manfredi, presentandolo come una delle sue tele più riuscite (LANDON
[1812], p. 39; PAILLET DELAROCHE [s.d. (1808)], pp. 103-104, n. 117). Nel 1924 Hermann
Voss, uno dei primi ad aver riabilitato l’opera di Régnier, gli restituì la Cena in
Emmaus ancor prima che l’inventario post mortem del marchese fosse stato rinvenuto
(VOSS [1924b], p. 126). Come per la maggioranza delle opere dipinte dall’artista a
Roma, la fattura è ricca, il tocco fluido, nonostante alcune piccole zone in cui la
pennellata appare non del tutto omogenea. Si osservi, ad esempio, il particolare
trattamento delle mani, molto curato: mescolando pennellate di rosso e di blu, Régnier ha
potuto rendere l’effetto diafano della pelle che lascia trasparire le vene della mano
di un vecchio. La natura morta, vista quasi in orizzontale, rende manifesta, in uguale
misura, l’influenza della tradizione caravaggesca e la formazione fiamminga
dell’artista. I motivi decorativi della tavola lignea e della sedia sono
minuziosamente descritti, così come alcuni dettagli delle vesti, tra cui spicca la
calzatura blu-argento del pellegrino a sinistra. Régnier usa degli artifici classici: il
piatto che esce leggermente dal bordo della tavola, la piega della tovaglia, la
giustapposizione dei vari oggetti. Egli gioca inoltre sulle trasparenze della caraffa
dell’acqua e del bicchiere di vino, così come sulle variazioni di luminosità e di
materia, partendo sempre dallo stesso colore: la porcellana bianca, la tovaglia e il pelo
dell’animale. Gli echi di colore conferiscono poi un’eleganza supplementare alla
composizione; in tale maniera l’alternanza di rosso e di blu delle vesti di Cristo è
ripresa nei motivi ornamentali del tappeto che copre la tavola. La tecnica di cui ci dà
prova Régnier nel trattamento della luce e della natura morta è un elemento essenziale
della sua arte che ritroveremo durante tutta la sua carriera, tanto nelle opere romane
quanto in quelle venete. Elaborata a partire dagli esempi di Caravaggio, la Cena in Emmaus
di Potsdam punta sui valori essenziali del soggetto e sulla sua risonanza sentimentale.
Régnier ha però proposto una lettura personale del tema, grazie all’inserimento di
figure incongrue e alla trasposizione dei "prototipi caravaggeschi" in una
chiave monumentale. La scelta di una composizione spinta sul fondo della tela e
leggermente spostata rispetto al celebre esempio del Merisi, un angolo prospettico meno
serrato e la presenza di un vuoto nella parte superiore della tela, creano un effetto di
grandezza assente in Caravaggio. A tale originalità si aggiunge la figura di Cristo, la
cui espressione dolce, con gli occhi levati al cielo e il volto inondato da una luce
diffusa, lo avvicina più alla scuola bolognese che alla tradizione caravaggesca. La
differenza di questi elementi compositivi, il formato della tela, così come la presenza
dell’aureola, partecipano tutti alla creazione di un’atmosfera solenne e
rivelano altre fonti d’ispirazione. Del resto la composizione verticale e, in modo
particolare, la monumentalità creata dallo spazio vuoto nella parte superiore della tela,
evocano il Cristo davanti a Caifa della National Gallery di Londra (vedi la scheda
corrispondente in questo stesso catalogo), uno dei tre quadri dipinti per Vincenzo
Giustiniani da Gerrit van Honthorst (SALERNO [1960], p. 98, n. 125), certamente prima del
1620, data della sua definitiva partenza da Roma. La Cena in Emmaus di Régnier fornirebbe
così uno dei primi esempi della fortuna di questo capolavoro di Honthorst; datata 1615 da
G. Papi e 1617 da J. Judson e R. Ekkart, quest’opera potrebbe costituire un possibile
termine ante quem per la tela di Régnier (sulla composizione di Honthorst, cfr. PAPI
[1999], p. 137; JUDSON-EKKART [1999], p. 82 e la scheda corrispondente in questo
catalogo). Altri dettagli contribuiscono poi ad accrescere la singolarità del dipinto di
Potsdam. Il servitore che si avvicina alla tavola non è ripreso da Caravaggio, ma sembra
piuttosto ispirato all’arte di Jacopo Bassano, del quale Vincenzo Giustiniani
possedeva diverse opere. Inoltre, l’aria austera della Cena in Emmaus sembra smentita
dalla presenza del grande cane bianco, posto in primo piano nell’asse prospettico
della composizione, che s’impone in piena luce al pari delle figure umane: una
posizione e delle dimensioni singolari che potrebbero spiegarsi con la destinazione
dell’opera e con una sua probabile collocazione in altezza. Tradizionalmente legato
al tema dell’Eucarestia, il cane della Cena in Emmaus, spesso rappresentato mentre
mangia delle briciole di pane, può essere un’evocazione della chiesa dei poveri.
D’altro canto, se l’animale appare sovente nel soggetto della Cena in Emmaus,
soprattutto in Veneto, nessun’altra opera gli accorda una tale importanza. Ci sarebbe
da domandarsi se l’insolita figura "en repoussoir" del cane di Régnier
potrebbe celare una citazione da una statua antica, mostrata in un’angolazione
incongrua, di schiena. Peraltro, sono numerosi i dipinti della collezione Giustiniani in
cui è possibile riconoscere tali richiami. Pensiamo al cane di Meleagro, celebre scultura
che ornava all’epoca il palazzo Pighini di Roma. D’altra parte l’opera è
così descritta nell’inventario del 1638: "un quadro grande di Christo a tavola
con dui apostoli, in fractione panis con il ritratto della Cagna Dama".
L’animale sarebbe dunque il ritratto della "Cagna Dama", probabilmente uno
dei cani di quel cacciatore appassionato che fu Vincenzo Giustiniani (Discorso sopra la
caccia in GIUSTINIANI [s.d., ed. 1981], pp. 81-98). Un’altra tela della collezione,
di mano di Joachim von Sandrart, merita di essere segnalata poiché anch’essa
presenta un cane come protagonista della composizione: "un quadro sopraporto con il
ritratto della Cagna Philide della razza di Bertagna, con un Inglese, che la tiene a
laccia" (SALERNO [1960], p. 98, n. 111); la tela di Sandrart è oggi dispersa (cfr.
KLEMM [1986], p. 318). Seguendo tale ipotesi, Régnier avrebbe introdotto nella scena
sacra un elemento della vita quotidiana del suo protettore. Mescolando con abilità il
sacro al profano, la Cena in Emmaus di Régnier appartiene a quelle rappresentazioni
"in quel mezzo fra il devoto, et profano", identificate, già nel 1603, dal
cardinal Paravicino nei quadri di Caravaggio (COZZI [1961], p. 44). Concepito come un
omaggio a Caravaggio e al suo committente, il dipinto di Potsdam è un’opera
ambiziosa, una tappa essenziale dell’iter romano di Régnier, forse il capolavoro di
questo suo primo periodo. La tela s’impone come un esempio emblematico, ma ignorato
sino ad oggi, della fortuna del maestro lombardo nella Roma degli anni 1610-1620,
comparabile alle grandi composizioni romane di Honthorst, di Baburen o di Spadarino.
Questo quadro resta però un’opera problematica perché s’inserisce con
difficoltà nella cronologia delle opere romane dell’artista. All’eredità
fiamminga ancora presente, si mescola la lezione di Caravaggio così come quella di
Honthorst o, più discretamente, dell’arte emiliana, annunciando le primizie di
un’evoluzione. Per la varietà degli stili di cui rivela la conoscenza, per le sue
dimensioni imponenti e per la sua discendenza dall’arte di Caravaggio, il dipinto di
Potsdam occupa un posto a sé stante nella produzione di Régnier, così come di grande
originalità rimangono tutti i dipinti eseguiti dall’artista per il marchese
Giustiniani. La cena in Emmaus sembra essere stato, all’epoca dell’artista, il
più grande dipinto mai esposto in un contesto privato, in questo caso una delle più
importanti collezioni del primo Seicento romano. Tanto per Nicolas Régnier quanto per
David de Haen o, ancora, per Valentin de Boulogne, sarebbe interessante sapere quale fu
l’importanza delle commissioni del marchese Giustiniani nello svolgimento della loro
futura carriera e quanto le tele della "sala grande dell’appartamento
nobile" del palazzo nobiliare contribuirono ad accreditare la fama di questi
"forestieri". (Annick Lemoine)
“Caravaggio 2025”: recensione con nuove osservazioni di Silvia Danesi Squarzina.
A PALAZZO BARBERINI DAL 7 MARZO: CARAVAGGIO 2025




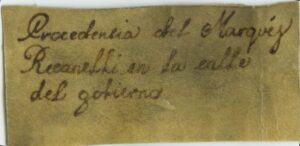
Da sinistra:1) Caravaggio, Ritratto di Maffeo Barberini (?), Firenze, collezione privata (in mostra, cat. 9) - 2) Ignoto scultore, Busto del cardinale Benedetto Giustiniani, Roma, chiesa di santa Maria sopra Minerva, cappella della SS. Annunziata - 3) Caravaggio, Ritratto di Maffeo Barberini (?), prima del restauro (Fototeca Zeri, n. scheda 46007) -
4) Caravaggio, Sant’Agostino, Londra, collezione privata - 5) Pergamena sul retro del Sant’Agostino di Caravaggio
Il catalogo della mostra "Caravaggio 2025" ha una introduzione di Alessandro Giuli, Ministro della Cultura, a cui segue uno scritto del Direttore di Palazzo Barberini, Thomas Clement Salomon, che enuncia il suo programma e che si è scelto il ruolo di ottimo regista dell’iniziativa, delegando le curatrici ai contenuti scientifici. Un comportamento in linea con i grandi direttori di musei europei o americani. Con tempismo impeccabile Salomon ha restaurato la facciata di Palazzo Barberini e ha scelto quattro belle e grandi sale a piano terreno per esporre i 24 dipinti in mostra, sperando di rendere agevole il flusso del pubblico, di cui era facile prevedere l’altissimo numero e che si è rivelato straripante. Il titolo della mostra, Caravaggio 2025, da lui voluto, sottolinea la concomitanza con l’anno giubilare in corso.
Salomon aveva, in prima battuta, saputo sollecitare la curiosità del pubblico presentando uno stupendo dipinto (cat. 9; figure
sopra prima e teraza da sinistra), mai esposto, segnalato da Roberto Longhi nel 1963 come Il vero “Maffeo Barberini” del Caravaggio, un esempio di altissimo livello della ritrattistica di Caravaggio, che, come dice Bellori, comincia a «ingagliardire gli scuri».
Non abbiamo la certezza assoluta che il personaggio effigiato sia Maffeo, il quale fra l’altro aveva gli occhi chiari, come attesta un dipinto a olio di mano di Bernini conservato a Palazzo Barberini, ma questo non diminuisce la bellezza della tela.
Ricordo l’emozione con cui vidi il magnifico ritratto presso l’attuale proprietario, grande mercante d’arte, moltissimi anni fa, insieme a Mina Gregori. Quanto alla individuazione del personaggio raffigurato è utile confrontare il volto del presunto Maffeo longhiano con un ritratto marmoreo di Benedetto Giustiniani nella chiesa della Minerva, lato destro, cappella della SS. Annunziata (seconda
figura da sinistra). La fronte, l’ovale del viso, le labbra sono di una somiglianza parlante. Quanto agli occhi, sappiamo da un ritratto attribuito a Bernardo Castello in collezione De Vanna (Bari) che erano marroni. La prima menzione, di non poco interesse, di un ritratto del cardinale Benedetto Giustiniani di mano del Caravaggio si trova nell’«Entrata della Guardarobba» di Benedetto Giustiniani, 1600-1611 ca., n. 98: «Un quadro del Cardinale Giustiniani naturale a sedere di mano del Caravagio. no I», registrazione di pugno del guardarobiere Alfonso Amarotti, post 12 settembre 1601. I confronti con gli inventari successivi sono riportati nella stessa pagina del mio volume e sono i seguenti.
Inventario post mortem del cardinale Benedetto Giustiniani, 1621, n. 122: «un retracto del Signor Cardinale facto dal Caravagio, senza cornice, in grande».Nessuno poteva conoscere queste notizie: il personaggio che deteneva il dipinto, venduto a uno spagnolo, era il marchese Pantaleo Vincenzo Giustiniani Recanelli, che nel 1857 era divenuto, dopo una lunga causa, l’erede legale dei resti della collezione Giustiniani e che si era insediato nel Palazzo.
Infatti, le parole scritte sulla piccola pergamena, sicuramente dalla mano del collezionista spagnolo che acquistò il Sant’Agostino, sono le seguenti: «Procedencia del Marqués Recanelli en la calle del gobierno». Queste sono due notizie che nessuno poteva avere: innanzitutto il nome del marchese Giustiniani Recanelli e inoltre l’antico nome della strada in cui si trovava Palazzo Giustiniani, calle del Gobierno, oggi via della Dogana Vecchia. I due studiosi che contrastarono questa individuazione, quando uscì sul Sole 24 Ore (12 giugno 2011), non fecero attenzione ai documenti. Il dipinto non si presentava in condizioni ottime in quanto era stato certamente trattato dalla restauratrice Margherita Bernini che usava quella che lei chiamava la “magica manteca”, un beverone a base di chiara d’uovo; la restauratrice era entrata in contatto con la famiglia Giustiniani attraverso Pietro Angeletti, estensore dell’inventario della collezione del 1793.
Inventario post mortem del marchese Vincenzo Giustiniani, 1638, II parte, n. 13:
«Un quadro d’una mezza figura, e più col ritratto della buona memoria del Signor Cardinale Benedetto Iustiniani dipinto in tela d’Imperatore di mano di Michelangelo da Caravaggio».
La somma di quanto dicono queste tre menzioni è estremamente esplicita e significativa per fare un confronto con lo splendido ritratto attualmente identificato come Maffeo Barberini. Si noti che la dimensione è la stessa, ossia tela d’Imperatore. Benedetto Giustiniani è chierico di Camera dal 1585, inoltre cardinale dal 16 dicembre 1586, per nomina di Sisto V.
Resta insomma da indagare più a fondo l’attività ritrattistica di Caravaggio, inesplorata soprattutto nella fase giovanile: alcuni nomi (ad esempio il Ritratto di Marsilia Sicca) restituiti dagli inventari restano incerti, anche se sostenuti da documenti.
Inoltre, per la fase giovanile è bene riparlare del Sant’Agostino Giustiniani (seconda
figura da destra): premesso che quando un dipinto è menzionato in un inventario è molto difficile essere sicuri che il quadro descritto sia quello che si sta studiando, nel caso del Sant’Agostino, invece, quanto è scritto sulla pergamena attaccata sul retro del dipinto (prima
figura a destra), al momento del ritrovamento, ci consente una individuazione senza dubbio alcuno.
Nessuno poteva conoscere queste notizie: il personaggio che deteneva il dipinto, venduto a uno spagnolo, era il marchese Pantaleo Vincenzo Giustiniani Recanelli, che nel 1857 era divenuto, dopo una lunga causa, l’erede legale dei resti della collezione Giustiniani e che si era insediato nel Palazzo.
Infatti, le parole scritte sulla piccola pergamena, sicuramente dalla mano del collezionista spagnolo che acquistò il Sant’Agostino, sono le seguenti: «Procedencia del Marqués Recanelli en la calle del gobierno». Queste sono due notizie che nessuno poteva avere: innanzitutto il nome del marchese Giustiniani Recanelli e inoltre l’antico nome della strada in cui si trovava Palazzo Giustiniani, calle del Gobierno, oggi via della Dogana Vecchia. I due studiosi che contrastarono questa individuazione, quando uscì sul Sole 24 Ore (12 giugno 2011), non fecero attenzione ai documenti. Il dipinto non si presentava in condizioni ottime in quanto era stato certamente trattato dalla restauratrice Margherita Bernini che usava quella che lei chiamava la “magica manteca”, un beverone a base di chiara d’uovo; la restauratrice era entrata in contatto con la famiglia Giustiniani attraverso Pietro Angeletti, estensore dell’inventario della collezione del 1793 [9].
 Torna alla homepage di Enrico Giustiniani
Torna alla homepage di Enrico Giustiniani
Torna alla collezione Giustiniani